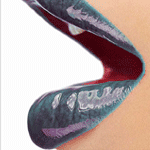- #
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
L’IRA DEL BACCANO – Terra 42
A 7 anni dall'esordio "Non Sedes Is - Live MMVII", L'Ira del Baccano si materializza sul pianeta con "Terra 42", attesissimo secondo capitolo delle avventure doomdelic rock partorito dalla formazione nata dalle ceneri dei grandi Loosin' O Frequencies. Alessandro "Drughito" Santori (chitarra), Roberto Malerba (chitarra, synth), Sandro "Fred" Salvi (batteria) e Luca Primo (basso) ottengono la complicità dell'agguerrita Subsound Records e ci inondano di quasi 60 minuti di sopraffina heavy psichedelia strumentale. Ispirato dal Douglas Adams del fondamentale "Guida galattica per gli autostoppisti", il gruppo ha ormai raggiunto una sorprendente maturità stilistica e compositiva. Uno stile riconoscibile tra molti, contraddistinto dai consueti e dovuti riferimenti (tanto per restare sull'ovvio: Black Sabbath, Hawkwind, Grateful Dead, Ozric Tentalces, Motorpsycho) e da una perizia tecnica che nel genere ha pochi eguali.
Le tre parti che compongono "The Infinite Improbability Drive" sono un'avventura spaziale assoluta: riff granitici e dilatazioni improvvise, synth ipnotici e ritmiche incalzanti (unico neo: l'eccessivo slapping di basso), valanghe di epico groove e una sana attitudine progressiva che evita accuratamente la masturbazione. Sul sentiero della Grande Dea Madre, "Sussurri... Nel bosco di Diana" è stoner doom gilanico che avvinghia e stordisce; esplorando l'infinito teatro del cosmo, "Volcano X13" è la summa del Baccano pensiero, l'attacco psichedelico sferrato dai temibili androidi Vorak per cancellare ogni residuo di sterile forma-canzone e fare della jam astrale l'unica e sola via d'uscita dal Caos.
Potremmo calcolare le nostre probabilità di sopravvivenza, ma non ci piacerebbe. La soluzione migliore è far girare sul piatto "Terra 42". Ancora, ancora, ancora...
DON'T PANIC.
Alessandro Zoppo
L’Ira del Baccano – Non Sedes Is – Live MMVII
Ancora una volta Roma e la sua provincia, ancora una volta un progetto che mai ti aspetteresti. L'Ira del Baccano, nuova formazione nata sulla scorta dei grandissimi Loosin' O Frequencies. Il quartetto è composto da Alessandro Santori (chitarra), Roberto Malerba (chitarra, synth), Sandro Salvi (batteria) e Massimo Siravo (basso, synth), in realtà sembra provenire da una galassia lontana e sconosciuta per come riempie le nostre orecchie e la nostra mente di note arcane, visionarie, distorte.
Un doom psichedelico strumentale devastante e onirico, che fonde la potenza spettrale di Black Sabbath, Saint Vitus ed Electric Wizard con i trip cosmici di Hawkwind e Gong. Chi si ciba di questo materiale troverà tante delizie nascoste in questo "Non Sedes Is - Live MMVII", dischetto auto-prodotto frutto di jam eseguite dal vivo e dunque registrate in presa diretta.
"Doomdance" è un inno, nonché biglietto da visita più che esemplare: atmosfere cavernose in puro stile Tony Iommi e fughe lisergiche da sballo totale. "875" fa leva su dieci minuti di magico eclettismo, tra wah-wah epocali, variazioni progressive e umori astrali. La perfetta colonna sonora alla 'Guida galattica per autostoppisti' di Douglas Adams, vera fonte di ispirazione per il gruppo.
"Tempus inane flago, requiem spatiumque furori" dura quasi venti minuti ma ha un riff così contagioso che ti ritrovi a canticchiarlo sotto la doccia subito dopo il primo ascolto, mentre "Don Bastiano" cita il mitico personaggio interpretato da Flavio Bucci nel 'Marchese del Grillo' ed è una cavalcata dal groove forsennato. "Sussurri di nascita celeste / Grateful to Jerry" chiude il cerchio con un tributo a Jerry Garcia ed i Grateful Dead, liquida ascesa verso cieli ancora inesplorati.
L'unica raccomandazione che rimane da fare è vederli dal vivo. Solo così si capirà fino in fondo la l'essenza primigenia dell'Ira del Baccano. Welcome to the new doomdelic instrumental rock story.
https://www.youtube.com/watch?v=wfhm5HT2S44
Alessandro Zoppo
L’Ira del Baccano – Paradox Hourglass
Il paradosso prodotto da
L’Ira del Baccano è quello di portare indietro la clessidra del tempo. Perfettamente strumentali, hanno l’appeal di quelle band che a cavallo tra i Sessanta e i Settanta esploravano l’universo musicale nelle forme più sincere e genuine.
Due chitarre, basso, synth e batteria per creare mondi magnifici. Attivi nell’underground musicale della capitale dal 2006, con “Paradox Hourglass” sono alla terza uscita dopo “
Si Non Sedes iS...Live” (un live di 56 minuti registrato in presa diretta nel 2008) e “
Terra 42” del 2014. Ma con questo ultimo album sembra che i quattro abbiano voluto completare e confermare in sintesi l’esperienza e la sensibilità acquisita fino ad oggi.
Si parte con la suite della title-track di venti minuti, divisa in due parti: “L’Ira del Baccano”, dove un riff alla Wino va a frammentare galassie synth e inframmezzi dolci e delicati come solo Jerry Garcia sapeva fare; il seguito di “No Razor for Occam” è più duro anche se risulta coerente con i passaggi precedenti. “Abilene” riporta in primo piano i riff, in questo caso più sabbatthiani e pesanti, ma sempre raffinati ed eleganti, come nella scelta di improvvise accelerazioni e cambi di tempo, prima di staccare i distorsori e diventare quasi desert song, anche se non è facile segnalare tutte le idee che i nostri mettono dentro un solo minuto di musica (come nel finale, dove rischiano di diventare dei Ronin della musica psichedelica pesante).
L’ultima “The Blind Phoenix Rises” piazza quasi a sorpresa un colpo cosmic doom come degli Electric Wizard di “Supercoven” o meglio i Sons of Otis (band canadese che univa granitici riff iommiani a space synth sporchi e cattivi), ma è solo l’inizio: poi viene messa tanta altra massa al fuoco che la vampa è impressionante. Questo è il paradosso dell’Ira del Baccano: suonare tremendamente retrò e tremendamente affascinanti.
[caption id="attachment_6057" align="aligncenter" width="640"]

L'Ira del Baccano[/caption]
Eugenio Di Giacomantonio
La storia di Hard Rock & Heavy Metal
Com’è finito il metallaro americano a vestirsi con spandex e lustrini? Cosa differenzia Joe Satriani da Steve Vai e Yngwie Malmsteen? Chi è Allan Holdsworth? Cosa pensava Dave Mustaine nel viaggio di ritorno verso casa, dopo il licenziamento dei Metallica? Chi è Brian Slagel? Cosa vuol dire thrash? Esiste una New Wave of Italian Heavy Metal? Quante canzoni grindcore possono stare in 12 minuti?
Bene, se vi interessa approfondire questi interrogativi, il libro di
Daniele Follero e
Luca Masperone è pronto a fornirvi tutte le risposte in materia hard & heavy con un piglio a metà strada fra compendio per gli appassionati e saggio per i ricercatori.
Manuale, piccola enciclopedia o almanacco,
La storia di Hard Rock & Heavy Metal mette in fila cronologica cinquanta anni ed oltre di musica pesante. Puntando l’ago del compasso sull’heavy metal, gli autori tracciano ellissi intorno al genere andando a costruire un albero genealogico che tiene conto di tutte le sfumature e contaminazioni che il genere ha subito negli anni, anche prima della sua stessa codificazione.
Sappiamo che i vasi sono comunicanti ed è difficile stabilire quando il blues sia diventato hard e poi heavy e quanto
sincronicamente abbiano agito nella sua trasformazione movimenti culturali e di costume come la
liberazione sessuale, i
movimenti per i diritti civili e la
controcultura giovanile, soprattutto perché questi eventi o fenomeni si sviluppavano da una parte all’altra dell’oceano simultaneamente, ma con sfumature e risultati diversi. O anche, e soprattutto, come le innovazioni tecniche sulla strumentazione abbiano influito sulla germinazione del termine.
Bravi comunque gli autori a fissare dei punti di riferimento, dai contorni sfumati, per restituire al lettore delle coordinate di riferimento. Citiamone alcune:
You Really Got Me dei
Kinks, primo pezzo nel 1964 ad utilizzare il power chord; l’amplificatore da 100 potentissimi watt del 1965 realizzato da
Jim Marshall per soddisfare le richieste dei
Who; la pubblicazione di
Vincebus Eruptum dei
Blue Cheer nel 1968 come album più rumoroso fino a quel momento e via dicendo, fino ad arrivare ai giorni nostri.
Immaginate, quindi, quanto materiale abbiano dovuto consultare Follero e Masperone per discernere gli aspetti significanti. Ovvie le mancanze che ognuno può contestare all’operazione (
Hawkwind e
Love su tutti, la serie
Brown Acid – fondamentale per capire la genesi del suono hard americano – ma anche il
meno ammissibile volo d’uccello sullo
stoner dei Novanta) ma tant’è: si tratta di fare una sintesi, non un elenco telefonico. Anzi, con una serie così complessa di fenomeni ed avvenimenti a cui hanno dato lettura, sono stati bravi ad uscirne fuori sani e salvi e a restituire al lettore la gioia del loro lavoro.
Il grande racconto di Hard Rock e Heavy Metal
Resta comunque chiaro il
focus dell’intera operazione targata
Hoepli: si può parlare di Heavy Metal in senso stretto solo nella
decade degli anni Ottanta e, anche se gli autori non lo dicono apertamente, risulta chiaro che dagli anni Novanta in poi, vuoi per il grunge che ha tagliato i ponti con la musica più prossima, vuoi per il crossover che ha mischiato elementi metal con generi apparentemente lontani, la musica metal
non esiste più. O, meglio, ha cambiato profondamente il suo DNA per sopravvivere.
È chiaro che ne esce fuori la figura del metallaro come figura aperta a nuove
trasmigrazioni del genere ma con in cuor suo il segno della fede impresso a fuoco. Tutto si traduce in un flusso continuo tra sotto e sopra il palco e, da questo punto di vista, sia gli autori che i fruitori del genere, ardono per la stessa passione e si riconoscono l’un l’altro come in uno specchio. Dobbiamo ammetterlo, caratteristica unica del genere, difficilmente riscontrabile in altri segmenti della musica popolare. Altro elemento d’attenzione è appunto l’appartenenza del genere al
proletariato e al
sottoproletariato di provincia. Esempi ce ne sono a bizzeffe e vi rimandiamo alla lettura del volume per verificare la dichiarazione. Unica eccezione: il black metal nordeuropeo apertamente misogino con vaghi spunti provocatori presi in prestito dal nazismo, in senso della difesa della razza ariana e della supremazia dell’uomo bianco.
Al contempo
Iron Maiden,
Black Sabbath e
Judas Priest (per citare solo i primi tre totem che vengono in mente) nascono e si nutrono dentro la fame di
riscatto sociale, tipica della classe operaia a cui appartengono.
British Steel è sì il titolo di un album chiave dei Judas Priest che dà il diapason a tutta la scena ma è anche il nome delle acciaierie di sua maestà. Intitolare un album con quel nome nel momento in cui Margaret Thatcher mandava a casa la metà dei lavoratori dell’acciaio ha senza ombra di dubbio il clamore di una dichiarazione d’intenti: noi siamo con voi.
Molto interessante l’approfondimento sulla
scena metal italiana di cui si riconoscono gli albori in band come
The Trip,
Biglietto per l’Inferno e
Il Balletto di Bronzo e che rivive nelle rievocazioni dei protagonisti degli anni Ottanta. Spassosa la ricostruzione dei primi anni dei
Death SS nelle parole di Steve Sylvester dove, in uno dei primissimi concerti auto-organizzati, il nostro manda a fuoco (involontariamente!) i folti ricciolini di Gigi Sammarco del duo comico Gigi e Andrea.
E si prosegue così, in un amarcord appassionato, dove incontriamo
Pino Scotto e Lemmy a bere Jack Daniel’s e a tirare coca nei camerini del Monsters of Rock o
Beppe Riva che ricostruisce la sua carriera di giornalista metal.
Altrettanto divertenti le incursioni nel gossip: il padre che litiga con suo figlio
Brain May appena dopo avergli costruito la famosa Red Special a causa della decisone del figlio di intraprendere la carriera da musicista; la copertina sbagliata di
Paranoid; il sacchetto di cocaina e i sorrisi nella copertina di
Live at Fillmore East della
Allman Brothers Band; le recensioni negative di
Lester Bangs al primo disco dei Black Sabbath: “Sono come i Cream, solo peggio”; la richiesta da parte dei
Van Halen di ottenere in camerino scodelle piene di M&M’s private di quelle marroni!
Insomma, una lettura per gli appassionati di musica Hard & Heavy ma anche per chi guarda al metal con vivida curiosità. Le prefazioni sono a cura di
Michael Weikath degli Helloween,
Aaron Stainthorpe dei My Dying Bride e Pino Scotto dei Vanadium.
Eugenio Di Giacomantonio
LAGHETTO – Sonate in bu minore per quattrocento scimmiette urlanti
Le vie della musica sono infinite e i Laghetto ne sono la dimostrazione. Il loro è il più assurdo e dissacratorio campionario di suoni e pensieri che sia mai capitato di ascoltare ultimamente. Hardcore? In parte. Psichedelia? Un pizzico. Crossover? Qualche traccia. E’ tutto l’insieme che delizia e sconvolge, basta analizzarlo con attenzione: il titolo del disco è “Sonate in bu minore per quattrocento scimmiette urlanti”, i testi sono surreali e grotteschi, l’artwork è curato in ogni minimo dettaglio, la musica varia in continuazione, passando da momenti folli ed estremi ad altri pacati e dilatati.
Per esseri più chiari, il cd inizia con un gorgheggio d’opera e si perde subito nei meandri di “Proud of my pappagorgia” e “Uomo pera”, hardcore evoluto o postcore, come diavolo lo si vuole chiamare, in ogni caso un mix di delirio e coraggio che fa paura. Splendidi schizzi psichedelici fanno capolino in “Requiem for CB” (dedicato alla memoria di Carmelo Bene), ritmiche sparate a mille, break momentanei e urla forsennate compongono “L’odore dei pomeriggi (quando li butti via)”, l’interferenza di un cellulare blocca “Devoured”, cover di Carla Bruni (!?). Ora giudicate voi se si può essere più insani di mente…
“Ninjacore”, con i suoi esasperati cambi di tempo, è il pilastro centrale su cui poggia l’essenza stessa dei Laghetto, l’estetica del ninja è presente in ogni sfaccettatura della loro incredibile personalità, simbolo di un modo antico di vivere il mondo di oggi. Passando attraverso il frammento post rock di “Armageddon in casa LaPenta” si arriva a “S.S. Napoli football players 1982-1989”, maniacale elenco di tutti i giocatori del Napoli delle suddette stagioni, da Rud Krol a Maradona, il cui nome è invocato a gran voce… per un gruppo di Bologna non male come astrazione mentale, no?
Il gran finale giunge con la strumentale e intricatissima “Gioele stai attento” (meno stupido di quanto si crede ciò che è riportato in proposito nel booklet: “La mamma aveva un figlio di nome Samuele. Adesso ne ha un altro e si chiama Gioele”…) e con “La mano senza dita”, atto finale di un cd che consacra i Laghetto a rivelazione assoluta del sottobosco sonoro italiano.
Un gruppo assolutamente delirante, geniale e diverso, ma nel vero senso della parola!
Alessandro Zoppo
LÄHDÖN AIKA + FROGSKIN – 7″ Split
Band entrambe provenienti dalla Finlandia e attive da circa un decennio e con vari full-lenght alle spalle, Frogskin e Lähdön Aika uniscono e le forze in questo sette pollici. Aprono i Frogskin con gli otto minuti di "Itse" all'insegna di uno sludge/doom lento, pesante e opprimente, con un growl cavernoso e accordi di chitarra sospesi su un drumming essenziale. I Lähdön Aika chiudono lo split con l'impronunciabile "Hiljaisuus kaikkialla" all'insegna di uno sludge con maggiori contaminazioni hardcore e crust, evidenziate sopratutto dal cantato. Pezzo più groovy del precedente, risulta comunque monotono e privo di inventiva. A conti fatti è netta la disparità tra le due band, l'ago della bilancia pende evidentemente a favore dei Frogskin sia per il songwriting, che nella sue essenzialità risulta comunque più convincente di quello dei Lähdön Aika, sia nel creare l'atmosfera e giocare con le dinamiche. Degno di nota il packaging dell'edizione, molto curato e accattivante, ma il prodotto è destinato comunque agli eventuali aficionados delle due band in questione, dato che nulla toglie e nulla aggiunge al percorso e allo sviluppo di entrambe.
Giuseppe Aversano
LAMONT – Muscle, guts and luck
I Lamont sono tre degenerati. Ragazzacci del Massachusetts in giro per saloon, pub fumosi e rodei dal 1998. Hanno alle spalle un ep e due full lenght (“Population 3” del 2000 e “Thunderboogie” del 2002). Questo “Muscle, guts and luck” è la loro quarta uscita, un mini cd di sei pezzi che li conferma come esponenti di punta dell’ala southern stoner più marcia e godereccia. Sono cresciuti a pane Mountain, Motorhead e Lynyrd Skynyrd i Lamont, ma nel corso dell’adolescenza qualcosa deve essere andato storto. Hanno scoperto il metal, i superalcolici e la droga. Solo così si può spiegare l’aggressività che caratterizza il loro sound.L’iniziale “Water me down” è una mazzata impressionante, il riff sudicio e la voce ruvida di Pete si schiantano sulle ritmiche quadrate di Jase (basso) e Todd (batteria). Ancora tanto groove lercio con “Raise a little hell” e “Cannonball”, rasoiate sparate a velocità supersonica. “Eightball” è il brano southern rock che i Motorhead non hanno mai scritto, “On the lam” abbozza una melodia che si stampa subito nel cuore e nel cervello. “Burn it down” è l’ultima meta di questo viaggio nel profondo Sud, una legnata assassina che suona come i Fu Manchu in pieno trip da delta del Mississippi.
Beer, coke, wiskey, weed. Let’s go.
Alessandro Zoppo
LAMONT – Thunderboogie
Brutti, sporchi e cattivi. Sembra il solito luogo comune ma è proprio questa l'immagine giusta per poter descrivere i Lamont. Giunti al primo album sotto l'ala protettiva della Traktor 7, questi tre loschi figuri (Mike Cosgrove, Pete Knipfing e Todd Bowman) hanno sfornato un dischetto duro e devastante come raramente capita di sentire. Il loro sound è una sorta di power southern boogie influenzato da gruppi del calibro di Alabama Thunder Pussy, Five Horse Johnson e The Glasspack.
Logicamente seguendo tali canoni viene dato spazio a chitarre grondanti riff lerci e "sudati", basso e batteria trapananti e una voce al vetriolo degna di un alcolizzato in piena sbronza. I brani si susseguono uno dietro l'altro senza lasciare un attimo di tregua: lo spazio concesso alla melodia è minimo (se ne percepisce l'odore solo nella conclusiva "Agent 49"), mentre prendono il sopravvento ritmiche selvagge, rutti, grugniti disumani e violente bordate al di sopra di ogni limite umano. L'unico difetto è una certa ripetitività che a tratti stanca, ma ci si passa sopra senza nemmeno pensarci in quanto siamo letteralmente travolti da tale fiume in piena. Tracce come l'iniziale "Hot wire", la scatenata "I saw red" o l'allucinante "Hell's got me runnin'" dimostrano l'abilità di una band compatta, capace di distruggere tutto ciò che si trova sulla propria strada.
A parte la travolgente ghost track (immaginate una versione ultra heavy dei Lynyrd Skynyrd ed avrete il risultato…) non c'è molto altro da aggiungere: "Thunderboogie" è un disco che spacca, diretto e doloroso come un pugno ben assestato alla bocca dello stomaco. Insomma, un acquisto consigliato per chi non sa quale musica mettere come sottofondo durante i propri festini lussureggianti…
Alessandro Zoppo
LAST MINUTE TO JAFFNA – Volume I
L'appena terminato 2008 ci ha regalato delle piacevoli sorprese e delle attese conferme per quanto riguarda il panorama italiano. I piemontesi Last Minute To Jaffna appartengono alla seconda categoria in quanto avevano già dimostrato di possedere stoffa da vendere con il promo di due pezzi rilasciato nel 2006 e reso disponibile in download gratuito tramite il loro sito. Il loro postcore debitore tanto ai Neurosis quanto ai Cult Of Luna si era dimostrato ricco di spunti e l'attesa per un lavoro sulla lunga distanza si faceva carico di promesse.Promesse mantenute perché i cinque lunghi pezzi (comprese le due songs del promo) proposti in questo "Volume I" confermano le belle parole spese nel recente passato. I LMTJ sanno come creare atmosfere ricche di tensione, tenerti sulle spine per poi tramortire i sensi con sferzate furiose. Prendete l'iniziale "Chapter X": la partenza calma e riflessiva ricorda i Neurosis più malinconici di "The Eye of Every Storm". Poi il sangue inizia ad andare alla testa, l'accelerazione è paurosa e le ferite iniziano a schizzare sangue. La parte finale è pura resa incondizionata… l'accettazione del dolore passa per ritmiche serrate e rutilanti.
Netta rispetto al promo del 2006 la sensazione di crescita dei LMTJ: l' "upgrade" maggiore lo si trova nella performance vocale di Valerio il quale varia ed amplia enormemente il suo range d'azione, veramente d'atmosfera ad esempio le parti pacate proprio della già citata "Chapter X" o di "Chapter V". Ma in generale sono gli ottimi arrangiamenti a dare una marcia in più a questo lavoro, la stratificazione del suono è importante e curatissima nei dettagli.
Non sappiamo quanto durerà l'hype delle così dette sonorità post, di certo i Last Minute To Jaffna firmano uno dei migliori lavori di genere proveniente dalla nostra penisola e ci auguriamo che la crescita della band piemontese continui anche nei lavori futuri. Acquistate questa offerta last minute senza indugi!
Davide Perletti
LAST MINUTE TO JAFFNA – Volume III
Uno potrebbe obiettare: "Dopo sei anni ve ne uscite con due canzuncelle e le versioni acustiche di tre brani dell'unico disco che avete pubblicato?". Un altro potrebbe esclamare: "Questo EP rappresenta un grande ritorno, avete raggiunto la maturità artistica, attendiamo impazienti il nuovo disco!". Decidete come schierarvi dopo l'ascolto: magari vi troverete a scegliere un altro punto più congeniale sul continuum tra i due estremi.Gianmaria Asteggiano (basso), Danilo Battocchio (chitarra), Valerio Damiano (voce, chitarra) e Andrea Pellegrino (batteria), dopo aver dato alle stampe nel 2006 il primo EP omonimo e nel 2008 l'eccellente esordio "Volume I", ritornano all'attenzione con "Volume III", che anticipa la pubblicazione del già registrato "Volume II". In questo EP (3 brani di "Volume I" e 2 inediti, come sottolineava il doppelgänger cinico a inizio recensione), i Last Minute to Jaffna si avvalgono del contributo di Fabrizio Modenese Palumbo (chitarra, kalimba, viola elettrica) e Stefano Casanova (flicorno tenore).
Il primo dei due brani inediti è "Chapter XIII": il flicorno tenore di Casanova arricchisce di sottili venature jazzy l'atmosfera crepuscolare di questa composizione, che strizza l'occhio allo slowcore più cupo. Poco dopo metà brano, l'incedere diviene ipnotico (anche grazie al lavoro percussivo) fino ad un crescendo convincente, per giungere alla chiusura del cerchio nel malinconico finale. Il secondo è "Chapter XXV", sul quale aleggia lo spettro di un Mark Lanegan particolarmente ubriaco (anche se i nostri citano l'apertura ad un concerto del nume Scott Kelly come principale ispirazione per questo lavoro), magari in combutta con qualcuno degli influenti musicisti della scena di Seattle (ma di certo non le "squallide meretrici svendutesi per compiacere quel mostro fagocitante di nome Mercato"), anch'essi persi tra fumi di sostanze psicotrope e tristezza.
I tre brani di "Volume I" ("Chapter V", "Chapter VI", "Chapter XI"), riarrangiati in chiave acustica (l'ultimo proposto in una registrazione dal vivo), fanno comprendere come i nostri sappiano scrivere valide canzoni ("Chapter VI" è quella che regge meglio il confronto con la "sorella elettrica"): queste versioni scarnificate ribadiscono perché si sia generata una fremente attesa per il nuovo disco.
Aspettando "Volume II", quindi, ho trovato la mia collocazione temporanea nel continuum di cui sopra e asserisco: "fatto bene, ragazzi!".
Raffaele Amelio
LAST STARFIGHTERS – May Silence Never Find Us
Devo confessare che da giorni cerco di scrivere qualche riga su questo EP della formazione italo/brasiliana Last Starfighters. Mi risulta difficile esprimermi in proposito, ma è arrivato il momento di consegnare il lavoro al grande capo, seppur con tempistiche doom. Premetto che la mia titubanza non si riferisce a carenze strutturali del disco, né a mancanze tecniche/emozionali della band. È che probabilmente ne ho sentita troppa di musica ultimamente. Tra le mani mi ritrovo "May Silence Never Find Us", quattro tracce dal suono curato quanto basta per far sì che il lavoro risulti digeribile. La band propone una mistura abbastanza efficace – sebbene indistinta – di rock che presenta una forte impronta moderna (fine Novanta and so on): in alcuni tratti sembra quasi di risentire il Marilyn Manson delle origini (1994-1997 per la precisione) tra le righe dei primi due brani, "Everything That Rises Must Descend" e "Blazed Stargazer".
Nella seconda metà l'EP sale a chiocciola e si sposta - continuando a muoversi nella stessa monade temporale – verso un sound più desertico, ripercorrendo più o meno agevolmente i classici del genere stoner. Una sviolinata di chitarre che ondeggiano tra Kyuss e Tool, senza pretese di massima originalità.
Ben suonato, "May Silence Never Find Us" non riesce a convincere sul serio: passa di fronte all'occhio della mente senza reazioni d'istinto. Non è brutto, non è bello: la band deve crescere, il groove della formazione deve crescere.
Che dire, questo disco – io – non l'ho capito. Ma in fondo sono la stessa persona che continua a non capire Mastodon e Pearl Jam, quindi non vedo quale sia il problema.
In fede,
S.H. Palmer
LAZY AMERICAN WORKERS – Surf lake erie
Dalla alquanto eterogenea Sin Klub arrivano gli spassosi LAW (Lazy American Workers), un terzetto che è riuscito a condensare 14 pezzi in poco più di 20 minuti. La proposta è per lo più basata su un veloce punk-rock abbastanza melodico a supporto di testi spesso e volentieri demenziali (riportati nel booklet con tanto di spiegazioni per le parti più criptiche o ermetiche, come ad esempio un riferimento al gioco Ms Packman…). Il risultato può essere estremamente divertente se preso dal giusto punto di vista, anche se a volte si sconfina nella confusione, soprattutto se non si riesce a capirne i testi che vengono sparati frettolosamente dal singer (onestamente è difficile seguirli anche con i testi sotto gli occhi…).
A sorpresa il CD si chiude con tre alcune cover, tra le quali una certa Revenge Of The Nerds dei Rubinos e un’inaspettata The Trooper presa direttamente dal repertorio di Bruce Dickinson & Co. (qui omaggiato anche in Nobody Bags Bruce Dickinson…), con una resa sonora non lontanissima dall’originale, anche se più povera dal punto di vista tecnico…
Questo CD può essere uno spasso insomma, ammesso che riusciate a recuperarlo ad una cifra molto contenuta…
Bokal
LAZY BUMS – Lazy bums
Prova coraggiosa questa dei Lazy Bums. La formazione marchigiana ci propina del sano e robusto hard rock di matrice americana. Venature blues e groove molto seventies per un debut album sanguigno e sincero.
Il nucleo principale della band nasce nel lontano 1996. La lunga gavetta nei meandri della scena più underground li porta a definire meglio le loro scelte musicali. Attualmente si compone di cinque musicisti. Le tastiere sono state sostituite dalle due chitarre per un suono più corposo e virulento. Anche la decisione di cantare i brani in lingua inglese li colloca in una dimesione poco provinciale. Insomma i presupposti ci sono tutti.
L'album, composto da dieci brani, scorre via piacevolmente. L'intro è affidato a "Bloody mirror" pezzo ben giostrato da Paolo e Tiziano con giri chitarristici che trasudano hard blues di tutto rispetto. "I don't care" è il mio pezzo preferito. Sicuramente il brano che più si avvicina a certe sonorità stoner a noi care. L'ottima prova di Maurizio dietro le pelli arricchisce una song da incorniciare. "Happiness" ci porta invece al grunge di Seattle mentre ad ammorbidire i ritmi serrati ci pensa "Shades", ballad nella più classica delle concenzioni american rock. "This is my blues" riprende il più classico dei giri di rock'n'blues. Di tutto l'album forse il pezzo più scontato, anche se non manca nemmeno in questo caso l'energia. "For the first time" è il brano più rock nel senso italico del termine. Melodie più orecchiabili e toni più morbidi. "Fool or mad" è invece un pezzo molto più sperimentale. Buona la prova dell'acustico anche se in alcuni frangenti mi sono venuti in mente i Creed. Il brano comunque si rivela interessante. "To you, for you" al contrario di "I don't care", è la traccia che più si allontana dalle sonorità a noi care... La successiva "My darkside" si dipana su un riff grasso e si conclude con un crescendo acido, mentre spetta alla conclusiva "Space mountains" riportare "l'ordine rock" nella più massiccia delle forme conosciute. L'album si conclude con un ghost track acustica. Un elaborazione di arpeggi chitarristici di buon livello.
Vario e multiforme questo debut dei Lazy Bums. Qui potranno trovare pane per i propri denti appassionati di stoner e di hard rock, cultori del rock'n'blues e del post grunge. La band si esibisce spesso anche dal vivo. Siamo curiosi di ascoltarli nella più cruda delle controriprove rock.
Peppe Perkele
LE SCIMMIE – Dromomania
Sono passati tre anni dall'EP "L'origine" e Le Scimmie tornano in forma smagliante per il primo full lenght completamente auto prodotto. Dieci tracce che segnano una frattura rispetto all'origine. Appunto. Niente voce, Angelo Xunah Mirolli e Mario Serrecchia si concentrano su chitarre e batteria. Mutazione strumentale minimalista originale e interessante. Identico è invece l'approccio low fi, che in questo caso si rivela una pecca perché rende i suoni molto pastosi ma poco incisivi."Dromomania" è un album che ha la sua arma migliore nella varietà dello stile e della proposta. Se infatti "L'oblio mistico" e "Dromomania" spingono su un versante oscuro e fragoroso (pensate ad un incrocio tremendo di Melvins, OM e Porn), le due parti di "Athazagorafobia" sono un trip psichedelico meditativo e a tratti malinconico. Segno che il songwriting c'è, ed è di pregevole fattura. "Frustrazione della psiche" e "Frekete" (Abruzzi flower power!) viaggiano su torbide frequenze stoner'n'roll: come se i Black Keys si fossero convertiti al segreto perverso dello sludge. "Il filo di lana" distrugge ogni residua speranza al suono di punk + noise. Vengono in mente Sonic Youth e Black Flag. Meri riferimenti in realtà, perché la materia è trattata in modo abbastanza sapiente. E quando si arriva al gran finale di "Nostofobia" non si può che bruciare all'inferno.
"Dromomania" è un disco ricco di fascino. Per Le Scimmie si apre un varco: con una produzione più a fuoco si candidano al ruolo di paladini della vita frustrata. Ovviamente a base di arrosticini e Nduccio.
Alessandro Zoppo
LE SCIMMIE – L’Origine EP
Le Scimmie. Vasto. 2007. Duo. Minimale. Energico. Grezzo. No schemi. Così si presentano Angelo (chitarra, voce, ukulele) e Mario (batteria), scimmie impazzite al disco d’esordio con quattro brani schietti e rabbiosi. Niente elaborazioni, qui si scrive, si suona e si registra. Approccio low-fi che non rende certo ottimali qualità ed incisività delle canzoni, che dona però un tocco vivo e pulsante al tutto.Si affrontano senza remore la psichedelia, il vecchio acid rock, il garage, il punk. E se ne esce indenni con un paio di riff serrati, dinamiche ritmiche semplici quanto efficaci, atmosfere elettrizzanti quanto basta. “Verrà (propedeutico a ciò che)” apre addirittura il dischetto con inquietati tagli elettronici, perché a saturare l’aria di scorie ci pensano la strumentale, sporchissima title track e la violenta “Siamo solo spoglie”. Sembra che i Motorpsycho siano passati da queste parti e si siano abbandonati al rumore bianco.
“Schizofrenia” chiude il cerchio con l’ennesimo riff sparato a mille e la batteria di Mario che segue a ruota. Schitarrate e pulsioni primitive che vanno incanalate in forma ordinaria per creare qualcosa di eccezionale. Attendiamo fiduciosi gli esiti dell’immediato futuro.
Alessandro Zoppo
LEADFOOT – Bring it on
Dopo la dipartita piuttosto infelice dai Corrosion Of Conformity, Karl Agell, il biondaccio sudista di origini svedesi, vive un periodo di profonda crisi personale: nonostante sia un validissimo vocalist e frontman, non riesce immediatamente a tornare nei circuiti che contano, e arricchisce il folto elenco di desaparecidos di lusso.
Dopo sei anni di oblio si ripresenta in gran forma e con una vera band, composta dagli eccellenti Fry e Barringer (chitarre), Swisher (basso), McClain (batteria).
Si tratta dei Leadfoot, gruppo che molti frettolosamente ascrivono al tornado dell’era post-Kyuss (forse per via della partecipazione alla mitica compilation “Burn One It Up”) commettendo però un’imprecisione: il piede di piombo in questione è quello di un nuovo molosso sudista.
La cosa che stupisce in positivo è che l’appesantimento sonoro apportato non lede minimamente il feeling e la coesione dei brani, e soprattutto non si assiste ad una collezione di canzoni revivalistiche, anzi: il southern rock di matrice hard sta riprendendo corpo con freschezza, e fra i massimi esponenti d’ora in poi ci saranno loro, i Leadfoot.
Inizio da spasimo con la title-track, in un tripudio di ritmo, riff e slide guitar a palla, con Agell sui suoi registri migliori (Morrison, Astbury, Medlocke) che incita ad alzare i vessilli fino a slogarsi le scapole, in una bolgia confederata.
Hard rock bluesato e possente con reminescenze di Atomic Bitchwax/Mountain è “Soul Full Of Lies”, forse il brano più stoner dell’album. “High Time”, “Roll Over You” e “Right Between The Eyes” sono da antologia, composte con intelligenza e sempre giocate su un potente feeling melodico, assolutamente irresistibili.
Con “Ripe” ci avviciniamo con molto piacere ai Molly Hatchet più ariosi, ma sempre con grossa personalità, e pregevole risulta anche “Sooner”.
L’highlight arriva però con il blues ultra-stonato e morboso di “Young Dumb Snake”, un tuffo in un canyon pieno di erba, crotali e barili di mescali. “Throwing Out The Baby” spacca davvero le ossa e suona come una session tra i Corrosion di “Blind” e i Blackfoot di “Marauder”.
Non è per niente finita, dato che si ritorna al galoppo con “Under The Sun”, con ancora un Agell indemoniato che si dibatte tra duelli chitarristici, proprio come si faceva una volta. “Naked Light” e “Forgotten One” arricchiscono ulteriormente il tutto: davvero nessuna canzone è superflua, credetemi.
Roberto Mattei
LEANAN’ SIDE – Yokozuma sound
Band emergente nel campo nell'indie rock, i Leanan' Side nascono nel 2001 e cominciano a farsi apprezzare tra Milano e provincia. Giunti al secondo EP autoprodotto, più una partecipazione ad una compilation edita da Sony Music Publishing, si apprestano ad uscire dall'anonimato con buone referenze e ottimi propositi.
"Yokozuma sound" vanta la registrazione e il mixaggio ad opera di Andrea Rovacchi (Marlene Kuntz, Timoria, Giardini di Mirò). Anche per questo, la qualità del suono risulta assai curata e di un certo spessore.
L'assalto frontale è immediato. "295.3" colpisce in maniera violenta e decisa. Un sound che ricorda un po' i Deftones e un po' i Soulwax, soprattutto il cantato si avvicina molto allo stile di Stephen, vocalist della band belga caduta nell'anonimato dopo un'ottimo album ("Much against everyone's advice"), prodotto nel 1998 da Chris Goss.
"River" ci porta su binari più classicamente rock, lasciando molto più spazio alle melodie. E' l'introduzione a "Leila's burns", brano prescelto per la compilantion "Saturday live club" edita dalla Sony Music. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad pezzo di ottima fattura tecnica compositiva, ma piatto da un punto di vista creativo.
Il ritmo aumenta con "Elephants", sicuramente il brano più riuscito assieme a quello di apertura. Peraltro la parte finale si snoda su cambi tempo d'impatto e di sicuro coinvolgimento in esibizioni live.
L'EP si conclude con una ballad, "It's no easy" malinconica e struggente.
I Leanan' Side risultano più convincenti nei brani più tirati. Il giusto mix di melodia e aggressività che riesce a sprigionare la voce di Riky in questi frangenti, è ben riuscito e di piacevole ascolto. Anche la sezione ritmica, di buon spessore tecnico, riesce ad elevarsi meglio nei pezzi più pestoni, mai confusi e impeccabilmente precisi.
I presupposti per fare bene ci sono tutti, vedremo quale strada seguirà la band nel prossimo futuro.
Peppe Perkele
LEATHER ALIVE – Loom
Come novelli Orange Goblin, i Leather Alive picchiano duro. Attivi nel territorio romagnolo dal 2009, hanno dato alle stampe il loro album d'esordio nel 2014 via Go Down Records, non prima di essersi fatti le ossa calcando i palchi in compagnia di OJM, Lords of Altamont, Vic du Monte e tanti altri. Gli otto pezzi che compongono "Loom" offrono il fianco alle influenze più disparate: si va dall'infatuazione per il deux-ex machina John Garcia in "Stream of Consciousness" dove il rifferama ci porta proprio a cavallo di Slo Burn e Unida, fino al crossover di matrice novanta di "Bonehead" e "Journey" che mischiano piacevolmente il sound di Seattle con i momenti più quieti di certo alternative rock in stile Jane's Addiction.
Alcune volte il cantato sembra restare un po' troppo fermo sullo stesso registro, ma è cosa da poco. Come il cantante dei Kyuss ha eletto a proprio modello Ian Astbury dei Cult, così il nostro Riccardo prosegue nella filiazione. Dalla sua parte c'è un substrato sonoro che vede due chitarre (Paride e Davide) e la sezione ritmica affidata a Nicolò alle pelli e Marco alle quattro corde. C'è anche una divertente sbandata redneck di "The Sniper" che se siete appassionati di Simpson non potete fare a meno di immaginare Cletus, l'allocco bifolco, battere il piede sul tavolato con in mano un boccione triple X. Così è il sound dei Leather Alive: ruvido, cafone, ma altamente genuino.
Eugenio Di Giacomantonio
LED ZEPPELIN – Led Zeppelin
ondra 1968. Jimmy Page, chitarrista proveniente dagli Yardbirds, decide di dar luogo ad una band fortemente ispirata dal blues, allora imperante in quel periodo. Basti pensare a gruppi del calibro di Beatles e Rolling Stones che stavano entrando nella piena maturità artistica mentre Cream e Pink Floyd si andavano facendo sempre più largo in mezzo alla massa.Page chiama allora alla sua corte Robert Plant, un giovanotto di Birmingham, John Paul Jones e John “Bonzo” Bonham. I quattro scelgono di chiamarsi Led Zeppelin rievocando il disastro avvenuto il 6 maggio 1937 e che diventerà la copertina dell’album. Il disco, registrato agli Olympic Studios di Londra nel 1968, uscirà però nel gennaio dell’anno seguente e sarà un vero e proprio fulmine a ciel sereno. L’inizio è un folgorante rock’n roll duro e puro, Good Times, Bad Times con la batteria di Bonham in prima linea. Segue la stupenda Babe i’m Gonna Leave You che si avvale della voce sensuale e penetrante di Plant ; si è detto che si tratta di un lavoro influenzato dal blues ed in effetti troviamo la presenza di due brani come You Shook Me e I Can’t Quit you Baby; il primo venne registrato da Muddy Waters nel 1962 e rivisitato magistralmente da Page, il secondo era un pezzo di Willie Dixon del 1956. Ma il capolavoro i nostri lo compiono con l’accoppiata Communication Breakdown (blues immerso nella psichedelia) e soprattutto con Dazed and Confused la canzone più importante dell’album (e non solo!). Quest’ultima diventerà un caposaldo per tutta la musica hard & heavy negli anni a seguire. How many more times, altro potente blues di oltre otto minuti, chiude un disco semplicemente straordinario, epocale, influente ed incredibilmente moderno. Da qui in avanti il Rock non sarà più lo stesso.
Cristiano "Stonerman 67"
LENTO – Earthen
“Il suono dei Lento è un tappeto di potenti chitarre ribassate, apocalittici tempi rallentati che affondano in droni e feedback”. Queste sono le parole finali della biografia acclusa a questo disco e mai parole furono più esatte. Evidentemente i Lento, quintetto strumentale di Roma, sanno e conoscono bene le proprie potenzialità e la propria natura sonora. Una line up dove figurano tre chitarre è garanzia di potenza, pesantezza e fisicità sonora. “Hearthen” è un blocco di cemento che avanza lento e subdolo, infiltrandosi nella mente e sommergendola nel suo monolitico incidere.L’iniziale “Hadrons” esemplifica il concetto, scorrendo cadenzata e potente, mentre “Subterrestrial” e la conclusiva “Leave” mostrano l’altra faccia dei nostri, esplorando soluzioni cosmic/ambient e dilatandosi in atmosfere space oriented. Molto bella l’onirica “Currents”, uno shoegaze metal alla Jesu, con le sue dense chitarre a vortice protagoniste anche in “Earth”, dagli efficaci ritmi sincopati. Per i fan di band come Neurosis, Isis da un lato e Mogwai, Pink Floyd dall’altro, un disco imprescindibile.
Marco Cavallini
LENTO – Icon
Le aspettative nei confronti di "Icon", secondo disco dei romani Lento dopo l'eccellente debutto "Earthen", erano molto alte. Due anni passati tra tour in Europa e reclusioni forzate in studio hanno partorito un risultato finale davvero riuscito. Complici anche le componenti esterne che rendono il lavoro un prodotto internazionale: produzione di Lorenzo Stecconi presso il Locomotore Studio di Roma (ormai garanzia di qualità); drum tracking di Matteo Spinazzè (Zu, Original Silence, Fm Einheit); mastering di James Plotkin (Khanate). I 37 minuti di "Icon" diventano così un'avventura oscura, spigolosa, labirintica, a cavallo tra postcore (se questa etichetta ha ancora un senso…), doom e ambient psichedelica.
Brani come "Limb", la splendida "Hymen" e la contorta "Dyad" giocano su riff che prendono possesso del corpo-musica. Quando questa magia accade, ci si ritrova a rotolare immersi in una materia putrescente. Inevitabile pensare ai primi Pelican, agli Isis o ai Cult of Luna. Tuttavia i Lento hanno acquisito nel corso di questi ultimi anni una consapevolezza del proprio suono che li eleva in un universo particolare. Un mondo dominato da chitarre mastodontiche, ritmiche pulsanti e ambientazioni nere e cibernetiche.
È anche per questo che si prova ulteriore piacere nel momento in cui episodi quali "Then", "Throne" e "Admission" rimandano ad una ambient music inquietante, vuota, misteriosa ed intensa. I frammenti quasi jazzati di "Hymn", le impalcature progressive di "Still" e "Least", le accelerazioni improvvise e spiazzanti (al limite del thrash) condite di svisate psych doom di "Icon" sono ulteriori indicatori di freschezza ed espressività importanti. Limando ancora qualcosa in termini di dinamicità ed immediatezza, i Lento potranno davvero essere protagonisti di un panorama musicale che sta diventando sempre più asfittico.
Alessandro Zoppo
LES BONDAGE – Try To Play It
Terzo disco per i Les Bondage, giunti a questo prezioso traguardo con un nuovo contratto firmato Go Down Records. Per il gruppo di Ravenna un punto d'arrivo e al tempo stesso di partenza, perché 'Try to Play It' condensa due anni di lavoro e dona finalmente stabilità alla formazione. Line-up che si è cementata su Lele (voce), Matteo (chitarra), Samu (basso) e Ale (batteria), coadiuvati per l'occasione dalle tastiere vintage di Mecco Guidi. Un sound grezzo e strafottente, in linea con quanto proposto nei precedenti 'Shake with…' (2002) e 'The Guy That Put You in Bondage' (2005). Garage rock'n'roll venato di punk, blues e glam, in linea con la tradizione gloriosa di New York Dolls, Fuzztones, The Cramps e Alex Chilton.Undici brani pungenti e scanzonati dunque, inni da strada che rendono omaggio ad un immaginario storico spesso perso di vista ("Down at the CBGB's"). Si passa con agilità dal rock sfrenato di "All My Friends Are Junkies" e "I'm In Love With the Girls" alla sensualità di "Mary Lou", dal surf boogie di "Surf City 99" al blues vigoroso di "I Got the Blues / Try to Play It", per giungere ad una chicca come "Saturday Night Is Comin'" e alla psichedelia deviata di "Near the Docks". Certo, l'originalità non abita qui. Però ci sono passione, piacere di suonare e sano divertimento. Caratteristiche sempre più dimenticate da chi si propone come paladino del rock'n'roll.
Non a caso, prima della ghost track di dovere, l'album si chiude sulle note di "Orange", ballata che profuma di David Bowie e Marc Bolan. Quando si dice che l'intelligenza viaggia di pari passo con il disimpegno.
Alessandro Zoppo
LES LEKIN – All Black Rainbow Moon
Nome curioso quello dei Les Lekin, a detta loro niente più che un divertissement nato dal nome inglese "Les" e dalla parola "Harlekin", tedesco per "Arlecchino". I tre – Peter Gallbauer alla chitarra, Stefan Willmann al basso, Kerstin Wolf alla batteria – nel 2011 cominciano a chiudersi in una sala prove nella zona industriale di Salisburgo e, in capo a tre anni, ecco l'album di esordio.
La via si apre con la consueta "Intro", breve invito ad addentrarsi nei meandri strumentali di "All Black Rainbow Moon"; pochi passi e ci si imbatte nell'ammasso granitico di "Solum", la chitarra che s'impone, diluendosi e addensandosi in un riffing ossessivo e inclemente, il basso che pulsa seguendo il moto circolare della batteria. La vista è nuovamente libera di spaziare sul panorama offerto da "Useless", almeno per qualche minuto, finché una colata di fuzz non torna a riempire le orecchie, saturando tutto in un alternarsi di riff grevi e melodie prodotte in assenza di gravità.
Con "Allblack" sembra di tornare sui propri passi, ripercorrere un sentiero già visto: il modello si discosta ben poco dal brano precedente, le soluzioni dinamiche sono vagamente ridondanti; a conferire un po' di movimento alla scena un paio di assoli simili più ad allucinanti sferzate di vento. L'immagine in "Loom" è sempre più sfocata, si dilata all'infinito: la chitarra è liquida, la sezione ritmica segue affannosa in un saliscendi senza pace, prima di piombare definitivamente in "Release". Ormai il percorso è quasi conchiuso, il viaggiatore è stremato, la mente vacilla, la visione è confusa, s'atrofizza e s'espande di continuo, fino a farsi nube di meteoriti nel finale, svanendo nello spazio profondo.
Un'esperienza singolare questo debutto dei Les Lekin, 49 minuti di jam strumentali ispirate "al deserto e alla luna, alla sabbia e allo spazio" e giocate su un canovaccio piuttosto scarno. L'album è stato infatti registrato in presa diretta, senza sovraincisioni, senza orpelli di alcun tipo, con l'intento di catturare l'esperienza sonora del trio salisburghese nella sua purezza, la stessa essenza primordiale fruibile in sede live. Se questo è un proposito apprezzabile, il rovescio della medaglia è che i brani si discostano assai poco l'uno dall'altro quanto a ritmiche e struttura, dando così un senso di eccessiva ripetitività. Reso disponibile dapprima in formato digitale e successivamente in CD autoprodotto, "All Black Rainbow Moon" ha comunque riscosso un certo plauso nell'underground heavy psych, tanto da suscitare l'interesse della piccola label tedesca Tonzonen Records, che pubblicherà un'edizione in vinile.
Davide Trovò
LEXUS – Indifferenti Idioti
I Lexus sono un progetto dark-sperimentale di Armando Greco, musicista che ha militato in alcuni gruppi punk del bergamasco, sorto per dare sfogo alla passione verso l'art rock e il post punk di nomi come Velvet Underground, Bauhaus, Virgin Prunes e Psychedelic Furs, approcciati con metodo minimale e anticonvenzionale (utilizzo oltre che di chitarra e basso, anche di effettistica vocale, didjeriddo, samples e strumenti quantomeno strampalati quali piastre e bastone della pioggia).Nel giungere a questo terzo "Indifferenti Idioti", i Lexus sono diventati un terzetto (ci sono anche Matteo e Gregorio nella formazione), dopo i primi due capitoli concepiti essenzialmente come one man band, e per promuovere la loro attività ricorrono a produzioni che più underground non si può: la PdB (Produzioni dal Basso), piattaforma orizzontale in rete per autoprodursi, e il Movimento Artistico Indipendente Flaneur.
Intenzioni sulla carta molto meritorie, ma che purtroppo non salvano dal naufragio amatoriale "Indifferenti idioti", seppur c'è da riconoscerlo con alcuni spunti interessanti e una istintiva simpatia per le intenzioni degli autori.
In effetti il cd trasmette - almeno in parte - sensazioni paranoiche da "stanza chiusa" che potrebbero considerarsi riuscite, però di contro il tipo di concezione 'antimusicale' con cui è stato realizzato lo penalizza irrimediabilmente, almeno alle orecchie di ascoltatori abituati ad altro tipo di sperimentazione (anche minimalista).
Comunque queste righe non sono certo la verità assoluta, quindi è giusto parlare lo stesso del disco e fare capire cosa ci ha trasmesso: la prima "Provole Soniche - Buchi del Culo Smerigliati" altro non è che una intro di due minuti di rumorismo distorto e varie percussioni su oggetti, voci angoscianti e qualche apprezzabile effetto in loop (ma solo quello però); "Pelle Smerigliata" e "Filo, Spada e pietra secolare" sono forse gli episodi più accettabili, ossia minimali shoegaze-rock battenti e/o giocati su atmosfere distorte, molto dark e con testi dissacranti; "Il cane, il coniglio e il fallo" parte invece per la tangente del nonsense e si riduce a samples ed effetti sul narrato cantilenante, cosi' come le varie "Stanze gelide", "Escatologici Pensieri" e "Meccanima" sono episodi trascurabili. "Nella Melanconia della Tristezza" dà in effetti in qualche maniera lo stato emozionale del titolo, però si tratta in fin dei conti di arpeggi distorti e effetti sonori molto semplici, cosi' come l'ultima "Idis". Probabilmente questo prodotto potrebbe avere i suoi estimatori, così come si possono sbagliare recensioni su dischi che magari poi si rivelano sinceri, però vi consiglio di passare oltre.
Roberto Mattei
LILI REFRAIN – Kawax
L'oscura Sacerdotessa Lili Refrain approda al terzo lavoro in studio nell'arco degli ultimi sette anni, il primo sotto l'egida di Subsound Records, etichetta sempre più eclettica e fuori dagli schemi. Chi ha assistito almeno una volta ad un concerto di Lili sa bene che i suoi sono veri e propri rituali e che la dimensione live enfatizza quelle che sono le sue caratteristiche, ovvero loop di chitarre e voci in tempo reale, senza l'ausilio di tracce pre-registrate, strato su strato, fino all'ipnosi. Non è affatto semplice trasportare questa dimensione così rarefatta sul disco, ma qui il risultato viene colto in pieno, a partire dal drone liturgico dell'opener "Helel". Il primo brano vero e proprio, "Kowox", inizia invece con un magistrale tapping super-metal, poi ingigantito da un palm-muting della miglior specie, a cui continuano ad aggiungersi livelli melodici intrisi di malinconia, fino a svuotarsi pian piano ed infine sfumare. "Goya" ha un incipit solennemente liturgico che farebbe impallidire Papa Emeritus e tutti i suoi Ghost, a cui seguono e poi si integrano inusitate chitarre gitane. "Tragos" diffonde canti mistici a capella, soavi echi lirici che arrivano quasi ad esplodere in urla di dolore. Il post rock onirico e strumentale di "Elephants on the Pillow" contrasta con l'ennesimo brano dominato dalla voce, quel "Nature Boy" in cui l'esile figura di Lili intona ciò che suona come una cupa ninna nanna cantata da un epigono mefistofelico a metà strada tra Björk e Diamanda Galas. In "666 Burns" la cowgirl del Demonio cattura la nostra attenzione grazie a chitarre dal malvagio sapore di sabbia, che sfumano poi nei delay di "Echoes" e di "Baptism of Fire" (quest'ultimo è l'unico brano ad avvalersi della presenza di una batteria, suonata da Valerio Diamanti dei Dispo). "Sycomore's Flames" chiude l'album con estrema grazia e gusto, grazie anche al violino del buon Nicola Manzan (Bologna Violenta).
Lili Refrain si conferma la first lady del circuito indipendente italiano.
Davide Straccione
LIP COLOUR REVOLUTION – Demo #01 – Demo #02 – Demo #03
Finalmente qualcosa sembra muoversi anche in Toscana, regione d’Italia prodiga di gruppi rock ma mai generosa in quanto a frange a noi gradite come lo stoner, il doom o la psichedelia. Ci pensano così i livornesi Lip Colour Revolution a mantenere alto il vessillo heavy psichedelico proponendoci una sana e rilassante mistura di stoner ed alternative rock.La band sembra essere in gran forma, tanto è vero che nel giro di un anno (tra la metà del 2004 e l’inizio del 2005) è riuscita a tirar fuori la bellezza di tre demo, roba non da poco insomma. Quantità e prolificità che non intaccano la qualità delle composizioni, in bilico tra acidità e armonia, rock dai tratti spigolosi e aperture ariose che donano gran respiro ai brani. Merito della duttilità vocale del singer Filippo, del lavoro “sporco” svolto alla chitarra da Alice e della possente base ritmica, composta da Gianni al basso e Dario alla batteria.
Il primo demo è composto da cinque pezzi e seppure acerbo rivela molti spunti interessanti. “Alone with the dwarf” e “Scirocco” ad esempio ci scuotono le budella con uno stoner robusto e corposo, di sicuro non molto originale ma ruspante e diretto, tra Dozer e Solarized, tanto per intenderci. “Gems” invece gioca più su iniezioni punk brusche e corrosive mentre “Zebra 3” e “She likes a groove” spingono sul tasto della melodia, accorpando elementi in stile Queens Of The Stone Age con altri che virano sull'alternative e l'indie rock. Un buon avvio insomma, giusto per far comprendere di che pasta sono fatti i quattro.
Il demo # 02 si presenta infatti più coeso e messo a fuoco. Registrazione migliorata (ma più per convinzione che per mezzi), brani tirati a lucido e un’esecuzione senza pecche. Resta una certa mancanza di personalità, tale da far risultare il sound già sentito. Ma poco male, siamo agli inizi ed è anche giusto che sia così, il tempo migliorerà le cose. Intanto noi godiamo di una song come “Mr. Deafman”, davvero un gran bel pezzo, stoner maestoso ed imponente, ricco di riff pastosi e dal tiro micidiale. Ovviamente senza disdegnare la successiva “Bling pig”, heavy psych di pregevole fattura, che oltre le esplosioni furiose privilegia le pause lisergiche e l'atmosfera pacata della psichedelica. Un punto in meno solo per la conclusiva “Gadara”: in questo caso viene privilagiato l'aspetto melodico e la potenza d'esecuzione passa in secondo piano. Si guadagna in appeal ma la carica perde irrimediabilmente.
Giungiamo così all’ultimo arrivato, il demo # 03. Lavoro che segna l’ingresso in line up di un altro chitarrista (Marco) ma sostanzialmente non muta le carte in tavola. “Smoking may reduce the blood flow and causes impotence” è infatti un missile stoner tirato e pastoso, nulla di realmente innovativo ma un sound ricco di spirito e sana passione, urgenza espressa da fuzz debordanti, ritmiche trita ossa e vocals al vetriolo ma sempre ben focalizzate sulla melodia. “Canadian girl” privilegia l’impatto punk (stile Mondo Generator) bilanciato dalla potenza del rock'n'roll; “The shape of silence” gioca sul piano della melodia languida senza però convincere pienamente: si tratta di un esperimento da riproporre in futuro ma in una chiave (di struttura e armonia) più delineata.
Dall’ascolto si ha dunque l’impressione che i Lip Colour Revolution si sentano a loro agio con la matassa stoner ribollente. Certe aperture indie alternative dovrebbero essere limitate o comunque inserite in un contesto meglio appropriato. Per ora le capacità ci sono, aspettiamo solo di vederle più mature in un nuovo dischetto.
Alessandro Zoppo
LIP COLOUR REVOLUTION – Lip Colour Revolution
Buon disco l’esordio dei toscani Lip Colour Revolution. Anche perché ne avevamo perso un po’ le tracce dopo i tre convincenti demo editi tra il 2004 e il 2005. E invece questo debutto omonimo rivoluziona le carte in tavola e ci fa scoprire un gruppo tosto e agguerrito, capace di variare genere e registro senza mai risultare piatto o di maniera. Un’ora di durata per un concentrato di heavy psych, punk, rock’n’roll, (in)sane dosi di alternative e sfumature anni 90. Filippo (voce e tastiere), Gianni (basso), Marco (chitarra) e Giacomo (batteria) si affrancano dall’ingombrante spettro stoner, sperimentando soluzioni nuove e assecondando umori differenti.Così, se l’inizio è di marca psicotropa made in Queens of the Stone Age (‘Smoking May Reduce the Blood Flow and Cause Impotence’, ‘Canadian Girl’), si passa con agilità attraverso malsane armonie di scuola Soundgarden (‘Zebra 3’, ‘The Shape of Silence’), sorprendenti aperture melodiche (‘Blind Pig’, ‘Vertigo’), punk’n’roll sporcaccione mutuato dal vecchio hardcore e dal revival di Nick Oliveri e i suoi Mondo Generator (‘Germs’), mood malinconici che rimandano a certi Pearl Jam (‘She Likes to Groove’, ‘Force of Nature’). La produzione di Giulio Favero al Blocco A di Padova esalta il tutto con suoni saturi ma mai compressi, la scelta giusto per chi si dedica anima e corpo ad un certo tipo di sound. Lo evidenziano anche il groove southern di ‘Electric Mama’ e la traccia nascosta posta a fine disco, un colosso heavy psichedelico che fa balzare dalla sedia.
Con un tocco di personalità in più e qualche riferimento ‘forzato’ di meno, i Lip Colour Revolution possono ambire a vette elevate. Perché le potenzialità ci sono eccome. Pollice su, anche perché l’album può essere scaricato gratuitamente dal sito della band.
Alessandro Zoppo
LLEORY – Juice Of Bimbo
Fermi tutti: se siete orfani di una certa concezione old-school di noise rock - ossia quella free, ipercinetica, violenta e aggrovigliata, che davvero se ne infischia di rientrare negli schemi intellettuali del post-rock da camera - procuratevi "Juice of Bimbo", primo album dei mud rockers Lleroy, trio di Jesi che vi darà una bella lavata di capo, e si riferisce a voi, negletti consumatori abituali di cibo in scatola, pusillanimi campioni abili solo a maneggiare quel fottuto joypad in interminabili sedute davanti allo schermo e che recate sui palmi le stimmate delle vostre frustrazioni sessuali. Cosa c'è di meglio che sbattersi sotto montagne di watt, versarsi addosso liquidi ustionanti e farsi una scorpacciata di note armoniose come una battaglia combattuta tra testate valvolari, pedali rotanti e cavi serpentiformi?Date retta ai Lleroy allora, mettete su il loro cd, che schiaffa subito il violento harsh noise di "The Lost Battle of Minorca", groviglio di riff alla Shellac, Pixies e Pussy Galore violentati sotto una pressa hardcore, per poi imbottirvi a dovere con gli steroidi della tiratissima e super ritmata "Magnete", in cui la voce di Frè si concede qualche scorticata strofa melodica.
La radicale "Debbie Suicide" vi apparirà come certi nervosismi di Unsane e Mevins,tra feroci matasse post-punk, ampli dolorosi e abbozzi psichedelici, fino a quando le vostre orecchie avranno modo di infiammarsi con una notevole tripletta: "In my Head", che riporta a Fugazi, Girls Against Boys, Voivod e inflitrazioni fuzzcore dal meritevole lavoro chitarristico (oltre all'incessante terremoto basso-batteria), "1-2-3 Kid", aggrappata ancora alle frange più violente del noise-psych americano, e soprattutto l'oltraggiosa "Testsuo", rifulgente di catalizzatori r'n'r in piena deriva fugaziana, che procurerebbe un bel macero in qualche malfamato centro occupato cyber-punk.
Non siete paghi? l'ipervandalica "Naked Violet" sa ancora dei Melvins più oltranzisti registrati con sessionmen hardcore fatti di colla, e per finire c'è pure il post-rock da laminatoio di "Border", cadenzata e angosciata marcia pre-industriale di vecchio noise ottantiano rielaborato in saturazione.
Totale massimalismo musicale bruciato in una adolescenza forzata, ma per fortuna ghigliottinata a dovere.
Roberto Mattei
LOFREQ – Everything, all the time
La furia del rawk’n’roll si abbatte su di noi, sono tornati i Lofreq! Li avevamo lasciati ai tempi del debutto “If this is the best ya got... we want our souls back”, alle prese con un immaginario sadomaso, ‘low & dirty’ ed un sound minaccioso, sludge fuzzy punk rock tanto rumoroso quanto debordante. Dopo quattro anni li ritroviamo lì dove li avevamo abbandonati: “Everything, all the time” è un disco tosto e coriaceo, che fa della propria varietà (un misto di rock grezzo e sfacciato, punk, stoner, garage, blues e hard sludge) il suo punto di forza, nonostante lo stile del gruppo faccia suonare il disco in maniera molto omogenea. Oltre questo pregio c’è anche una sana dose di violenza che non guasta mai in ambiti del genere (o degeneri?).“Soulstealer” e “Joyride” sono esemplari a tal proposito: rock sfrontato e carico di groove, da far impressionare i Melvins quanto gli Hellacopters e i Glasspack. Sulla stessa scia (di sangue, birra e sudore) si muovono “Your mind will die the same way it was born” e “Wreckingball”, mentre “The heat” azzecca il giusto giro appiccicandosi immediatamente in mente. Melodia a presa rapida che contraddistingue anche il blues sanguigno di “Naughty naughty”, sonorità che si impongono prepotenti in “A new smooth”, esaltate da un’armonica bollente che porta dritti dritti all’Inferno (o sulle rive del Mississippi, fate un po’ voi).
“(Back to the) Garden of Eden” è il ritorno alla nostra natura primitiva, puro istinto che prende sopravvento sulla ragione e la spazza via a colpi di riff. Ottimo modo per chiudere un album che fa dell’impatto e della mancanza di regole la propria forza. Concludiamo dicendo che il disco è auto prodotto. Nessuna paura però, si può acquistare su ITunes attraverso il sito della band. Un metodo altrettanto valido per farsi travolgere da una simile furia.
Alessandro Zoppo
LOIMANN – Aechmea
Aechmea, piante appartenenti alla famiglia delle Bromeliaceae originarie dell’America tropicale. No, niente floricoltura, è solo lo spunto utilizzato dai torinesi Loimann come titolo del loro promo d’esordio. Dischetto dalla gestione piuttosto travagliata: dei sette brani presenti, i primi cinque sono stati registrati nel 2006 da Fabio (voce, chitarra), Edoardo (basso) e Sandro (batteria); gli ultimi due nel 2008 con una formazione completamente diversa. A Fabio si affiancano infatti Dario al basso e Enrico alla batteria. Tuttavia c’è sostanziale continuità tra i due periodi, merito di Fabio che crede nell’idea e prosegue ostinato in questo progetto.La aechmea dà fiori colorati, tra il giallo, il rosso e il blu. Sfumature che si percepiscono anche nei pezzi dei Loimann: la base è un heavy rock tosto e potente, tendente allo stoner di matrice scandinava. Le nuances sono invece influssi metal, hard, punk e rock'n'roll. Come dimostra “Razor”, bolide dedicato a Dimebag Darrel. “Collision” e “Bull” rappresentano alla perfezione lo stile del trio: rock robusto, focoso, carico di groove. Stesse vibrazioni che emanano la title track e “Ground”, tegola tutta rabbia e velocità. Se solo la registrazione fosse stata maggiormente curata e ci fosse stata qualche melodia più ‘appiccicosa’, queste cinque canzoni avrebbero potuto comporre un ep in piena regola.
“If You Dare” e “Keep the Distance” sono il nuovo corso dei Loimann. Partenza incoraggiante per il futuro perché qui ci sono gran tiro e carica selvaggia. Avanti così per l’Augusta Taurinorum stoner.
Alessandro Zoppo
LOIMANN – Towards Higher Consciousness
Il progetto Loimann nasce a Torino, e dopo anni di dura gavetta, tre dischi autoprodotti e concerti un po' ovunque, ha finalmente trovato il momento di decollare e incidere il primo lavoro in via ufficiale grazie alla One Voice Recordings, label di recente costituzione situata a Chivasso.Il trio, formato da Fabio (voce e chitarra), Dario (basso) ed Enrico (batteria), si muove tra sonorità stoner, sfuriate sludge, qualcosa di grunge, più interessanti e moderne aperture psichedeliche che ricordano in alcuni momenti quanto fatto recentemente da gruppi come Baroness e Intronaut.
I dodici brani non presentano particolare varietà e questo potrebbe costituire un limite ma anche un fattore positivo, in special modo per coloro che amano certe atmosfere cupe e tenebrose presenti in buona parte dell'album. Nonostante ciò bisogna sottolineare l'estro di "Lycopodium" ed il magnetismo di "Tetrodotoxin" che, senza nulla togliere agli altri pezzi, suonano più vari e curati nei dettagli.
Dove possiamo invece dare un consiglio è sulla voce, a volte sin troppo avvolta negli effetti utilizzati; maggiore pulizia vocale in certi frangenti potrebbe migliorare il risultato finale. Per il resto "Towards Higher Consciousness" è un disco ben suonato che va assaporato ascolto dopo ascolto e non deluderà gli adepti del genere.
Continuando in questa direzione i Loimann non potranno che togliersi meritate soddisfazioni.
Cristiano Roversi
LOINEN – Loinen
Tornano a distanza di un anno da "Noiseferatum" i finnici Loinen, con un nuovo full-lenght dal titolo omonimo (come il debutto del 2007). Band atipica nel panorama sludge contemporaneo, alfieri del lo-fi e con quel gusto weird che li rende assimilabili a band come i redivivi Nightstick e i compianti Karp. Mancanti di chitarra e forti di due bassisti in formazione, i quattro partono a spron battuto con "Portto", uno sludge mefitico e ossessivo; ripetizione del riff allo sfinimento e scream malato. "Kuolemanselli" e "Tässä Talossa" non cedono di un centimetro, anzi, inaspriscono il discorso aumentando di dinamismo. "Ruumishuone" con la sezione di archi che intona una melodia malinconica mentre sotto continua imperterrito il massacro sonoro, impreziosisce e stacca dal trittico d'apertura. Dopo una ripresa dei toni standard e una leggera apertura black metal con "Sekaisin", è il turno di "Jerusalem". Il canto intonato da un muezzin viene inframezzato da una batteria freeform e dal cantato che si trasforma dallo screaming dei primi pezzi a un lamento continuo, ossessivo e disturbante. "Kumijeesus" è la cavalcata che fa da preludio a "Hyödytön Eläin", pezzo di chiusura: oltre nove minuti di progressione, stop e ripresa del tema fino all'ossessione e alla conclusione tirata, manifesto della musica targata Loinen. Il quartetto finlandese pubblica quello che finora è il loro lavoro più solido e anche malsano. Uno sludge cattivo, infimo e con un piglio freak, consigliato a tutti coloro che amano il lato più weird e sperimentale del genere in questione.
Giuseppe Aversano
LONG DONG SILVER – Bound To Bleed
Viziosi, determinati, sarcastici, travolgenti e pure decisamente sfacciati, i Long Dong Silver approdano finalmente al primo Lp vero e proprio, dopo l'omonimo mini CD (autoprodotto, 2002), compilation e split (entrambe su Scarey Records) e soprattutto diversi tour in Europa e USA, in cui hanno diviso il palco con urticanti band stoner/r'n'r che continuano ad agitarsi noncuranti di qualsivoglia trend. Il merito è solo uno: la formula esplosiva che imperterriti i LDS continuano a proporre. Rock'n'roll alla Hellacopters/Turbonegro/Datsuns/Hanoi Rocks appesantito e inacidito, e infatti non è difficile ravvisare anche influenze stoner rock, glam-punk e hard'n'heavy (leggasi Kiss, Blue Cheer, Kyuss, Suede, Pawnshop). L'approccio rimane comunque sempre snelllo e sinuoso, come dimostra in primis l'assalto distruttivo della title-track, ben pilotato dalla voce versatile e vissuta di Datura Stramonium, frontman all'altezza della situazione e spesso decisivo.L'anima NY Dolls/Stones emerge invece nella seconda "People Like It Rough", che anticipa un anthem ad alto voltaggio: "Generation Masturbation", brano notevole con chorus sentiti e accattivanti. Il mid tempo di "Spike Heals & Leather Mask" suona come una versione aussie-rock dei Backyard Babies, ossia crepitante hard equilibrato da insinuazioni sleazy.
A sorpresa "The Beast Inside Your Heart" si avvicina alle folgorazioni modern-blues dei Masters of Reality (periodo "Sunrise on the Sufferbus" per intenderci), "Alcazar", "Some 1.2.8" e "Live To Get Fucked" sono hard rock che impastano Misfits, Dead Boys, Stooges, Glucifer e lo stoner, e per concludere il party finale garagista arriva con la sfrontata energia di "10.000 Years of Pain".
Una volta si diceva che per ascoltare un disco rock'n'roll fatto come dio comanda bisognava fare qualche migliaio di chilometri; provate a mettere "Bound to Bleed" e ne riparliamo.
Roberto Mattei
Lord Buffalo – Tohu Wa Bohu
Tohu Wa Bohu, il debutto dei
Lord Buffalo, è un ritorno alle radici più profonde della musica americana, all'innocenza dell'infanzia, all'abbraccio di Dio. Il quartetto racconta verità religiose, credenze, dubbi e paure dell'essere umano sempre più confuso di oggi. Senza saggezza mistica o calvinismo apocalittico, bensì affidando ad una potente sincerità l'esplorazione del nostro lato oscuro.
La storia dei Lord Buffalo è come tante altre.
Daniel Pruitt (voce, chitarra) e
Garrett Hellman (chitarra, organo) crescono insieme a Stillwater, in Oklahoma. Suonano negli Shiloh Fivecoat e quando si trasferiscono a Austin, in Texas, formano gli
Hot Pentecostals, che diventano ben presto un'istituzione locale.
L'ennesimo scioglimento non ferma la coppia: Daniel e Garrett reclutano
Patrick Patterson (violino) e
Yamal Said (batteria e percussioni) e mettono su i Lord Buffalo. La band definisce la propria musica in modi diversi:
mud folk,
forêt noir,
Crappalachian butt rock.
Etichette corrette perché
Tohu Wa Bohu, il secondo album (lanciato da Blues Funeral Recordings: altro centro con
Lowrider,
Big Scenic Nowhere e
Elder) dopo l'esordio omonimo del 2017 (si può ascoltare sulla pagina Bandcamp della label
Clerestory AV), è un lavoro che mischia
psichedelia dark e
folk cantautoriale, e lo fa con un sound oscuro e polveroso, notturno e vibrante.
Camminiamo nei coni d'ombra dell'
alt-country e del
Gothic Americana attraversando queste otto tracce. Immaginate Arbouretum, Dead Meadow e Black Angels da una parte, Nick Cave and the Bad Seeds, Wilco e Woven Hand dall'altra.
La sensazione è quella di passeggiare per le strade di una
città fantasma dove il tempo si è fermato, tra
paesaggi notturni apparentemente ostili e sinistri, ma dannatamente magnetici, con l'asfalto spaccato dal sole e le anime degli abitanti cadute nell'oblio.
Con il santino di Roky Erickson nel portafoglio, Pruitt evoca antiche
atmosfere di provincia cariche di segreti, come un predicatore che infiamma le folle promettendo salvezza e misericordia. I suoni sono cupi e profondi, come nelle emozionanti
Raziel (un crescendo così capita raramente di ascoltarlo) e
Tohu Wa Bohu (l'intreccio di voci è da pelle d'oca), ed ipnotici e opprimenti, nel caso di
Halle Berry (un richiamo al profondo sud torbido e fangoso di
Monster's Ball) e
Heart of the Snake, una ballad lenta e vaporosa che genera un dolore palpabile.
Nella loro dolcezza, punteggiata dalle note leggere di
pianoforte e
violino,
Dog Head e
Kenosis affrontano questo percorso di espiazione con un'americanità minimalista da brividi, quasi ad evocare il lato tenero di David Lynch e Angelo Badalamenti.
Svuotato di tutta la sua furia,
Tohu Wa Bohu si chiude con la desolata
Llano Estacado No 2, una traccia strumentale a lenta combustione, come le braci morenti di un fuoco che si spegne nel profondo di una
foresta di montagna.
La solitudine, il senso di colpa, la forza catalizzatrice dell'amore: tutto questo vive nel debutto dei Lord Buffalo, capaci come pochi di esprimere il malessere, le emozioni e la furia della passione.
https://www.youtube.com/watch?v=UtUEsu4a_A4
Alessandro Zoppo
LORD FOWL – Moon Queen
I Lord Fowl sono un quartetto che giunge da New Haven, Connecticut. La proposta del gruppo è un hard rock fortemente influenzato dai 70's che annovera tutti gli ingredienti tipici del genere, dal rock blues al tocco funky all'heavy riffing, fino al moderno heavy stoner psych e ad un lieve fervore grunge, senza disdegnare l'aspetto melodico, specie nell'uso delle vocals. Il suono dei nostri affonda dunque le radici nell'hard rock, in particolare di band quali Mountain e Sir Lord Baltimore, ma grazie al gusto melodico che traspare nei vari brani, è evidente come la band sia stata ammaliata anche dai suoni che precedettero l'AOR di formazioni come Legs Diamond, Starz, Ted Nugent, Boston ed affini. Gruppi che si fecero portabandiera di uno stile sì heavy – fondato su granitici riff – ma dall'innegabile gusto vellutato.Con "Moon Queen" i Lord Fowl tagliano il traguardo del secondo album centrando pienamente il bersaglio. Grazie ad un eclettismo che non li rende mai ripetitivi, questo disco è assolutamente godibile e non sfigura tra le migliori proposte dell'anno appena concluso. Un termine di paragone che può calzare con i nostri sono i Graveyard: a differenza degli svedesi la band statunitense dispone sicuramente di un inferiore carisma e di un minore approccio bluesy, seppure al pari degli autori di "Light Out" i quattro abbiano una notevole capacità compositiva, abbinata ad un tocco melodico persino più accentuato. Insomma, i Lord Fowl sono una macchina macina riff tra hard rock, proto metal, stoner rock e hard AOR.
Antonio Fazio
LORD SHANI – Progress Your Soul
Nella storia recente stiamo assistendo ad una nuova ondata di band con lead vocals al femminile. Spiders, Blue Pills, Siena Root e moltissime altre band, compresi i nostrani Alix sono la dimostrazione che un nuovo feeling, sexy e sensuale, sta contaminando la musica psichedelica. E proprio a questo genere si ispirano i Lord Shani che, a dispetto del nome del gruppo, vede la bella Viola protagonista nel sound della band milanese. L'album d'esordio "Progress Your Soul" rappresenta una sorta di riuscito mix tra le fantastiche allucinazioni orientali dei Siena Root e una rilettura, robusta e distorta, delle dodici battute in chiave blues dei Blue Pills. Il risultato è straordinario.Non solo quindi nostalgia di enormi idoli quali Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Cactus, Cream, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jefferson Airplaine, ma una consapevolezza, data soprattutto dalla maestria tecnica, di appartenere ad una modernità che è del terzo millennio. Si guarda indietro, ovvio, ma per catturare gli elementi rappresentativi e genuini della musica heavy psych. Qualcosa è dolce e soul come la conclusiva e dilatata "White Is the Sky" e l'appassionata "Duel"; qualcos'altro è potente e funky con tanto di ribollio ormonale alla Red Hot Chili Peppers come "Fight"; altro ancora gode di una scrittura finissima e facilmente orecchiabile come "Am I Surprised", "A Day" e l'opener "Told You So" e qualcos'altro rappresenta un'eccezione come la strumentale "Cosmic Ordeal", viaggio al termine dello spazio conosciuto. Il tutto suona compatto ed emotivamente coinvolgente: un vero fuoco sacro dal calore bianco. Bravissimi.
Eugenio Di Giacomantonio
Lord Woland – Below
Venti minuti di fango e suoni grassi. I
Lord Woland, trio
tufo stoner rock (definizione che varrebbe da sola amore incondizionato!) di Bolsena, ridente cittadina dell'omonimo lago a nord di Viterbo, pestano duro.
Partono come un mammutone di granitico sludge doom in "Abra Cabala" (devono avere un talento naturale nel trovare i nomi giusti...) e si frantumano in una cavalcata proto heavy nelle vicinanze di 7Zuma7 e Orange Goblin.
"Woland's Hall" ha un riff bellissimo di stampo Wino e un ritornello irresistibile. "Rotten Apple" ha un'apertura maggiore e punta dritta verso le band Seventies guitar oriented. Fanno venire in mente i Taste dell'immenso Rory Gallagher e questo è un bene. La conclusiva "Gloominade" rallenta per un attimo il ritmo, ma è solo un impressione: dopo tre minuti e mezzo l'ignoranza ritorna padrona.
I ragazzi ci sanno fare e sanno dove possono arrivare. Se si è interessata a loro la
Mother Fuzzer Records di Dublino un motivo ci deve essere.
[caption id="attachment_5986" align="aligncenter" width="800"]

Lord Woland[/caption]
Eugenio Di Giacomantonio
Lords of Altamont – The Wild Sounds of Lords of Altamont
Jake Cavaliere è l’immagine del rock’n’roll. Dopo Lemmy, ovviamente. Dai Fuzztones, ai magnifici Bomboras, ai
Lords of Altamont (black humor, Jake?) insegue un’idea, un modo di vivere, una fede.
Cosa ha di diverso questo
The Wild Sounds of Lords of Altamont dagli altri album pubblicati dalla band? Proprio niente. E questo è il bello. Perché sono tutti perfetti nel misurare la classe dei nostri in canzoni quasi sempre al di sotto dei tre minuti. Ecco. Forse in quest’ultimo c’è un’urgenza (
Been Broken) espressa con più
urgenza (il tempo passa, vero vecchio Jake?) e i pezzi hanno subito, per quanto possibile, ulteriori perfezionamenti.
Chi volesse entrare nel loro mondo incontrerebbe
sing a long in salsa southern come
Take a Walk, erotismo deviato alla Turbonegro in
Going Downtown,
Death On the Highway e la cover di
Evil, classico di Willie Dixon portato al successo da Howlin' Wolf e già rifatto dai Monster Magnet di
Superjudge.
Per gli amanti della psichedelia c’è da godere in odore di space rock motorick con
Revolution (altre band come
500 Ft. of Pipe hanno prodotto lo stesso magico suono) e per i
Nuggets addict ci sono perle come la tripletta
Fever Six,
I Say Hey e
Can’t Lose.
Si finisce come in chiesa con
Where Did You Sleep che sembra la perfetta unione tra Motorhead e Girlschool con l’aggiunta dell’Hammond. Questo è quanto. Jake insegue una fede. E noi con lui.
https://youtu.be/ide1q3-LiJQ
Eugenio Di Giacomantonio
LOS FUOCOS – Revolution
"Revolution" è il disco d'esordio dei giovanissimi Los Fuocos, nuovo lancio di casa Go Down Records. Immaginate un furioso, melodico e accattivante concentrato di scan rock (The Flaming Sideburn, The Hellacopters, Gluecifer, tanto per intenderci), cali punk, garage e hard tradizionale (The Stooges, MC5, Motorhead). Il risultato sono i 40 minuti che compongono questo dischetto fresco, genuino e soprattutto ben suonato. Perché il trio di Lodi scrive canzoni che scorrono lisce come l'olio, ruvide e al tempo stesso solari, inni da strada ma anche spensierate esperienze sonore da party alcolico.Pado (voce, chitarra), Mike (batteria) e Den (basso) sanno essere incisivi e potenti, quello dei Los Fuocos è infatti un rock'n'roll che non sorprende certo per originalità, brilla piuttosto per impatto e franchezza. Si passa da razzi veloci e taglienti ("Suzanne", la bellissima title track, "Honey", "Sometime's Better Lose the Fight") a melodie ammalianti che non dimenticano mai rabbia e sporcizia sonora ("Great Raid Dreaming", "Rely On Me"). "Danny the Mind" è impreziosita dal sinuoso hammond di Alessandro Bellomo, mentre sul finale troviamo una frizzante rilettura beatlesiana di "Day Tripper". La chiusura è affidata a "The Rock Empire", colosso di puro rock'n'roll che vede ospite alla voce Lu Silver degli Small Jackets.
È dunque una appassionante avventura "Revolution". Grazie alla Go Down che ci regala l'ennesima, valida band italiana da seguire con attenzione.
Alessandro Zoppo
Los Natas – Corsario Negro
Chi viene dall'Argentina come i
Los Natas e suona
stoner psichedelico non lo fa certo per fare il figo con le bellissime ragazze sudamericane o per pagarsi l'affitto. Lo fa per farlo, punto. Perché è estremamente piacevole chiudersi in sala prove la sera e costruire con i tuoi
hermanos lunghe jam fumose rette da muri di fuzz scarni e vocals pregni di riverbero naturale.
Con
Corsario Negro i Los Natas riescono ad affrancarsi definitivamente dallo status di clone-band dei Kyuss maturando uno stile che è sì una naturale estensione di quello della band californiana ma proposto in maniera molto personale.
Innanzitutto il suono è più asciutto, la voce è usata in modo molto naturale (e in lingua originale) e le origini ispaniche vengono finalmente sfruttate a pieno. Innanzitutto nel ritmo, elemento centrale per ogni stoner band che si rispetti, e nella capacità di creare con la musica paesaggi aridi e polverosi di provenienza extraterrestre. L'album è un continuo work in progress, un susseguirsi di brani a cui i limiti di inizio e di fine si sente che stanno molto stretti.
Dopo l'introduzione solenne di
2002,
Planeta Solitario è una cavalcata possente tenuta in sospensione da implosioni psichedeliche regolari, un tira e molla che alza l'aspettativa su un eruzione definitiva che in verità non arriva mai.
Patas de Elefante ne è una naturale prosecuzione con l'aggiunta di maggiore calore e colore improvvisativi. Il brano si apre serrato, si arrotola, il drumming cambia incedere con frequenza, i cori sono carichi di riverbero, le chitarre trovano praterie infinite per infilare liberi fraseggi di wha wha.
Tra cariche di battaglia suonate da un piano alla Jerry Lee Lewis (
Leit Motive) e confortanti intermezzi acustici (
Hey Jimmy), il
Corsario Negro giunge finalmente a destinazione e non può che rimanere esterrefatto - e noi con lui - da ciò che gli si presenta davanti. In
Contemplando la Niebla e nella title track la band argentina mette a nudo tutta la sua
hispanidad polverosa e arida applicata al rock pesante realizzando un brano di altissima emotività nel primo caso e un magnifico esempio di jam session psycho-stoner con un cuore rosso e pulsante nel secondo.
Un grande album.
https://www.youtube.com/watch?v=Q1XfXmudOO8
Francesco Imperato
Los Natas – El Nuevo Orden de la Libertad
A distanza di tre anni dall'ultimo lavoro in studio ("El Hombre Montaña", Small Stone Recordings), intervallati dalla pubblicazione di una doppia raccolta di B-sides e materiale vario ("El Universo Perdido de Los Natas", Meteorcity Records), la curiosità per il nuovo lavoro dei
Los Natas è stata soddisfatta.
In primo luogo perché né la raccolta, né gli Ararat - progetto pseudo-solista di Sergio Chotsourian (chitarra e voce della band argentina) che ha pubblicato l'esordio nel 2009 - hanno placato la sete dei fan e dei sostenitori del trio sudamericano. Fortunatamente l'attesa non è stata vana ed i consensi hanno premiato gli sforzi e le idee della band, regalandoci un altro grande lavoro che li piazza saldamente al vertice delle formazioni della Esse3, scena stoner sudamericana.
Per dovere di cronaca bisogna dire che qualche critica, a volte eccessiva, c'è stata e non sarebbe corretto nasconderla: i detrattori puntano il dito contro la minore vena psichedelica e l'abbandono di sonorità che avevano contraddistinto gli ultimi lavori, come le "Munchen Sessions" e le "Toba Trance". Reazione che non è assolutamente fuori luogo, perché l'allontanamento dalle componenti lisergiche c'è ed è evidente ma non è così netto da aver causato un inaridimento del suono, piuttosto è un parziale ritorno alle origini della band. Grandi origini, se si considera questo lavoro come un ponte con le prime produzioni, ossia "Delmar" e "
Corsario Negro", dischi che avevano permesso ai Natas di godere di un'ottima visibilità oltre i confini nazionali.
Il primo grande elemento che si mette in luce è la matrice 'mariachi', l'uso dell'acustica e degli accordi caldi e vibranti della tradizione latina, che ripercorre per tutto il disco dall'attacco di "Las Campanadas" alla chiusura di "Dos Horses", cavalcata strumentale arricchita dal piano suonato da Santiago Chotsorian. L'atmosfera evocata dalle note pizzicate risuonano anche nella romantica e malinconica "Bienvenidos", così come nelle prime note di "El Pastizal".
La scelta del cantato, sempre evocativo e d'effetto, è un altro punto a favore dell'ottima prova di un gruppo che ha da sempre creduto nella scelta dello spagnolo anziché cedere alla facilità dell'inglese. Il resto del disco si carica di momenti molto più pesanti ed epici, quasi ai confini con lo stoner metal, ma che riflette di una certa personalità quasi epica ("Resistendo al Dolor", "Hombre de Metal", "El Nuevo Orden de la Libertad"), per poi cedere il passo alla bellezza disincantata e intima di "Ganar, Perder". Quest'ultimo intermezza i brani più carichi di groove e dinamici, come "David & Goliath" e "10.000".
Tecnicamente eccellente, con una sezione ritmica in gran tiro, "El Nuevo Orden de la Libertad" detta l'ordine di partenza ed i Los Natas sono saldamente in pole.
https://www.youtube.com/watch?v=LEvuGVqBJNE
Gabriele 'Sgabrioz' Mureddu
Los Natas – Toba Trance II
Suscita totale emozione ogni nuova uscita dei Natas, i più grandi musicisti sudamericani di tutti i tempi di rock psichedelico, e la loro inaugurazione del corrente anno su supporto discografico, è affidata alla seconda parte di Toba Trance, il misterico viaggio negli angoli più reconditi del grande cono argentino.
LOSS – Life without hope… Death without reason
Soffia vento di morte sul Tennesee, patria dei Loss, autori di un doom metal mortifero e funerario, dove iconologie quali lamette e cappi per il collo sono la normalità.“Life without hope... Death without reason” suona come la sua copertina, come la disperata morte di un suicida, così come il dolore dei propri cari, come la fine di ogni speranza.
“Coffin Nails” è un semplice intro fatto di feedback e sussurri angosciosi, che spianano la strada ai successivi pezzi, lunghi blocchi di disperazione ed angoscia, che pescano dalla negatività di Thergothon ed Evoken e dalle atmosfere decadenti dei primissimi Anathema.
“Conceptual funeralism unto the final act (of being)” e “Cut-up, depressed and alone”, sono la pura tragedia umana, lenta ed inesorabile. Splendidi brani trascinati da un growl gutturale e quasi impercettibile, e da i colpi del rullante che scandiscono con il proprio eco la processione funebre. A tutti gli effetti sono questi gli unici due brani degni di nota, dato che le due tracce seguenti sono dei pessimi esempi di registrazione live (molto) low-fi, registrate al The End di Nashville. La prima di queste registrazioni è una cover dei Katatonia, trattasi di “Brave”, che vede come guest vocalist Lord Imperial dei black metallers Krieg. La song si conclude con oltre 30 secondi in cui il chitarrista accorda la chitarra, abbastanza inutile come cosa. La seconda registrazione è invece “The barebacked burial of a torn angel”, molto più verso lidi death-doom di scuola inglese (primi Paradise Lost e My Dying Bride), con ritmi lenti ma meno asfissianti, se non fosse per il solito problema della pessima registrazione...
Un lavoro riuscito a metà insomma, i pezzi “veri” sono solamente due, mentre gli altri due sono catalogabili come bootleg in quanto a qualità.
Ci troviamo comunque di fronte ad una band valida, capace di annichilire e suscitare emozioni contrastanti, sicuramente un colpo sicuro per gli amanti del genere.
Buon funerale!
Davide Straccione
LOST DREAM – The Beauty Of The Dark
Un’ottima sorpresa arriva dai Lost Dream, solidissima formazione nel cui sangue fluisce tutto il migliore sound che ha fatto grande la nostra musica, dallo stoner rock, al grunge, all’hard’n’metal sabbathiano.Il potente impianto bluesy che fa capo ai Lost Dream trova piena espressione nelle mani di Stefano, Domenico, Luigi e della cantante/chitarrista Enza D’Ambrosio (che voce!! tra Chris Cornell e Mike Farmer !) e sfocia in un moderno heavy rock che trasuda feeling in ogni singolo passaggio, un po’ alla maniera di grandi gruppi come Loudmouth e Spiritual Beggars, anche se i Lost Dream hanno quel certo retrogusto alternative metal che li rende differenti e dal mood tutto particolare.
Magari scomodare questi nomi potrà sembrare esagerato, ma vi garantisco che il talento c’è tutto, manca forse solo una leggera messa a fuoco, ma sono perfezionismi, visto che potremmo già avere l’ennesimo gruppo competitivo sui palcoscenici dell’underground europeo (che alla fine sono quelli che contano, se si bada al contenuto prettamente musicale).
Il primo brano “Suck & Smile” è un possente hard rock denso di ipnotismi stoner psichedelici, e basterebbe da solo a inquadrare il valore del gruppo, che non si capisce davvero come possa ancora essere impigliato nella ragnatela delle autoproduzioni, ma deduco che sia solo questione di tempo. “Queen Of Absenthium” parte con un incipit psych soffuso per poi svelare tutto il suo groove mammuth, mutuato da Helmet, Unida e Godsmack. “I Don’t Mind” è una lega di inossidabile stoner rock con mid-tempo cadenzati fino allo stordimento, fraseggi hard-blues e partiture che rimandano parecchio agli Alice in Chains di Dirt, così come “Strange Perception” è un altro vortice hard psichedelico, metallizzato di tinteggiature doomy. “You’re Not Afraid”suona un po’ più ibrida, con elementi di Tool, Karma To Burn e Zed Yago (!) ma è pur sempre un pezzo valido che non stona nel contesto generale. Great!
Roberto Mattei
LOST MOON – King of dogs (promo)
Ritorno sul pianeta terra per i Lost Moon. La band capitanata da Stefano (voce, chitarre) emette nuovi segnali di vita con questo promo di sei pezzi riservato agli addetti ai lavori, ghiotta anticipazione di un disco già pronto (il secondo, dopo il debutto omonimo), contenente i sei brani qui presenti più altri cinque nuovi di zecca.Il tiro e la grinta che contraddistinguono il gruppo beneventano non sono svaniti negli spazi siderali. Il ‘re dei cani’ è sporco, grezzo, ‘stoner’ nel cuore e nell’anima. Il sound che viene fuori è furioso, devastante, nonostante le composizioni siano ancora prive del mastering definitivo. Heavy psych è il termine adatto per descriverlo, un incrocio di hard rock e attitudine lisergica mutuato dai padrini Black Sabbath e passato al setaccio dai discoli Monster Magnet. La presenza delle percussioni rende il risultato definitivo ancora più ancestrale, un vero e proprio trip senza via di ritorno.
I riff giganteschi che esaltano song come “Fly with the wind” e “Nature in black” sono puro godimento per chi adora la psichedelia heavy e le calde sonorità degli anni ’70. Uno spettro di possibilità compositive che i Lost Moon aprono anche su altri versanti, come quello tribal acustico di “Return (to cradle of madness)” o quello southern psych (!) di “N.H. 2000”, episodio davvero riuscito. La title track conferma invece il piglio tirato e ruvido della band, mentre “Going to Neputne” è un gioiello di dark space rock che segna il culmine del promo, un intreccio di riff magmatici, ritmiche dense e vocals provenienti da pianeti lontani e galassie sconfinate.
In attesa del full lenght completo, il return trip si fa veramente difficile.
Alessandro Zoppo
LOST MOON – Lost moon
La scena musicale di Benevento (specie in ambito rock) è quasi del tutto morta: dopo l’ascolto dei Lost Moon scopriamo con immensa sorpresa che questi quattro ragazzi hanno al loro arco numerose e acuminate frecce... Uscito nel 2002 per la Lostlands Rek. (etichetta indipendente fondata dal gruppo stesso per l'autodistribuzione e l'autopromozione della propria musica), l’album "Lost moon" si dimostra un disco compatto, variegato e soprattutto ricco di idee: le coordinate sonore vanno ricercate nei meandri del dark sound psichedelico degli anni settanta, sotto l'egida dei numi tutelari Black Sabbath.
Ma non si tratta della solita "xerox-band" che prende i riff di Mr. Tony Iommi e li rielabora senza capo né coda: su un tappeto fatto di aggressività e potenza si calano esplosive schegge psichedeliche, rigurgiti punk e acide contaminazioni tribali. Ovviamente il lavoro presenta i suoi difetti (una registrazione decisamente non all'altezza ed alcuni suoni troppo scarni e poco corposi), ma si tratta di aspetti su cui poter passare sopra e non solo per il nostro senso campanilistico...
La base solida su cui piantare un futuro roseo c'è e lo dimostra un brano come l'iniziale “Light inside”, che, preceduto dall'“Intro” molto onirico e visionario, parte in quarta per merito dei riff tirati e dei wah-wah lisergici di Stefano Paolucci, anche vocalist dall’approccio a volte strettamente melodico, a volte più ruvido, supportato ottimamente dal drumming possente del fratello Pierluigi e dal basso avvolgente di Adolfo Calandro. Una particolare attenzione viene riposta anche nei testi, nei quali viene posto l'accento sui viaggi introspettivi e sulla rabbia che genera il vivere nel degrado e nella frustrazione della società di oggi, quindi un altro punto a favore del quartetto...
Un’ottima rappresentazione per il tipo di tematiche trattate è proprio “Flow”, song di heavy rock a tinte oscure dove le chitarre si fanno sabbathiane fino al midollo (la cavalcata finale è davvero da brivido...) e la sezione ritmica viene impreziosita dalle percussioni di Mauro Colloca. La successiva “Burnt” riporta alla mente i fasti dei Motorhead, piena com'è di irruenza e attitudine punk venata di collera e sdegno che culmina nel “fuck you liars” del chorus...le acque si calmano invece con la seguente “Acoustick”, momento rilassato e meditativo molto zeppeliniano nel suo ricamare tessiture di folk gaelico e di lirismo ipnotico, con qualche sbavatura però nelle parti di chitarra solista. A riportare il lavoro su sentieri contorti e mesmerici ci pensa “Cradle of madness I”, oltre sette minuti di acid rock cupo e mellifluo, che se da un lato fa pensare ai primi Soundgarden (specialmente in alcune accelerazioni dal mood plumbeo e ossessivo), dall'altro riverbera cascate di feedback e distorsioni asfissianti e psicotrope, merito di uno Stefano perfettamente a suo agio nel martoriare la sua sei corde in modo liquido e morboso.
Ci avviamo così verso la conclusione, non prima di aver attraversato le lande desolate di “Lostlands” (appunto...), episodio ancora una volta votato alle sonorità che hanno reso celebri Ozzy e compagni, con un tocco doomy a dare una scossa lugubre al tutto e una coda ultradilatata che riprende forza solo per concedere la mazzata finale. La chiusura dunque avviene con “Cradle of madness II”, vortice strumentale fatto di sinuosa heavy psichedelia tribale, portata ai massimi livelli dal basso slabbrato di Adolfo e dall'ottimo gioco a due di chitarre e percussioni.
In conclusione, i Lost Moon si rivelano un'ottima realtà in un desolato panorama musicale come quello beneventano, se sapranno limare alcune angolature spigolose del proprio sound potranno davvero fare un balzo di qualità decisivo. La volontà e il coraggio ci sono, quindi non ci resta che augurare loro un caloroso in bocca al lupo...
Alessandro Zoppo
LOST MOON – Tales from the Sun
Tornano i Lost Moon, altra band veterana del nostro folto sottobosco, la creatura dei fratelli Paolucci che affonda le sue origini addirittura agli albori degli anni 90, e che col tempo ha affinato il sound che la contraddistingue: un heavy rock di scuola Sabbath, Soundgarden, Floodgate e in minima parte anche Tool, filtrato da un proprio solido background. Questo è il terzo album ufficiale, dopo l'ottimo "King of Dogs" (2008) e l'esordio omonimo del 2002; rispetto al suo predecessore, imperniato su atmosfere paniche e notturne, e nel quale facevano capolino talvolta gustosi tribalismi etnici, "Tales from the Sun" punta dritto verso un immaginario di distopica sci-fi permeata di esoterismo (terzo occhio docet) e aspra critica sociopolitica, e quindi il suono si avvicina a uno stoner metal futuribile e aggressivo. Le dosi di groove sono presenti in modo massiccio negli assalti di "Adrenalin's Flowin'", "Tales from the Sun" e "Burn America", mentre un altro ceffone che ricorda i Monster Magnet di "Powertrip" potrebbe essere "Lay Your Hands Down on Me". La fluttuante psichedelia di "The Path I Walk" ed episodi di hard mutante come "Ransom" e "Event Horizon" contribuiscono a ispessire ulteriormente l'ascolto. Un condensato di space/doom/stoner arriva infine dalla possente "Building a New Wall". Non si fanno prigionieri.
Roberto Mattei
Lost Moon – Through the Gates of Light
I
Lost Moon tornano in pista più cattivi che mai.
Through the Gates of Light è la loro prima uscita per l’agguerrita etichetta tedesca
Pink Tank Records. Ne è passata di acqua (o di gin, fate voi) sotto i ponti dai tempi dell’
omonimo autoprodotto del 2001. Da allora Stefano Paolucci (chitarra e voce) e i suoi sodali (Pierluigi Paolucci alla batteria, Adolfo Calandro al basso) hanno suonato in lungo e in largo per l’Europa e inciso un altro paio di full-length,
King of Dogs nel 2007 (uscito via UK Division/PHD) e
Tales From the Sun nel 2013 (edito da Karma Conspiracy Records).
Through the Gates of Light porta alle estreme conseguenze il percorso musicale avviato da Stefano sin dai primi anni Novanta. Prendere il verbo sacro dei Black Sabbath, frullarlo nel mixer alcolico '90s e restituirlo “dignitosamente brillo” (per dirla con Alberto Biggiogero, uno che di stoner se ne intende). “Rabbia, passione, energia, elettricità, primitive pulsioni psichedeliche” sono gli elementi che ritroviamo – come da propositi belligeranti – nelle otto tracce del disco.
Stavolta i Lost Moon abbracciano la capacità di sintesi e il risultato è evidente. Questo lavoro suona secco e diretto, ben prodotto e amalgamato. Nei 36 minuti di durata ritroviamo tutte le caratteristiche che contraddistinguono il gruppo beneventano. Dalla foga belluina heavy metal alla magia visionaria dei Settanta, passando per l’estasi lisergica della psichedelia e il groove assatanato dell’hard rock. Con una parte centrale che è la vera delizia di questo viaggio:
Pilgrimage è il miglior brano mai scritto dalla band e
I Got Drunk Again una chiara ed evidente dichiarazioni d’intenti. La luce interiore rispunta nella conclusiva
Visions, dove tra i fumi stordenti compare un sitar a riconciliarci con la più profonda essenza di noi stessi.
Through the Gates of Light scorre via che è un piacere, tosto e dinamico, conciso e
heavier-than-fuck. Niente fronzoli, nessuna divagazione, solo tanto rock’n’roll saporito e semplice come un bicchiere di buon bourbon.
[caption id="attachment_6078" align="alignnone" width="640"]

Lost Moon[/caption]
Alessandro Zoppo
LOTHORIAN – Welldweller
La seconda uscita di Acid Cosmonaut Records è qualcosa di maligno. La descrizione dell'ultimo giorno sulla terra. O qualcosa di simile. Gli autori, provenienti dal Belgio, sono i Lothorian. I cinque devono aver fatto una grossa scorpacciata di Electric Wizard, Sons of Otis, Warhorse e tutto quel doom tinto nella psichedelia più scura, fino a risultare una divagazione space olocaust. D'altra parte le band provenienti dai Paesi Bassi hanno sempre avuto una particolare propensione verso la combinazione di elementi chiari con elementi scuri. Basti ricordare un gruppo come i Toner Low, a cui i nostri si avvicinano molto: ottima scrittura e imprevedibilità. Come scardinare l'ortodossia doom e risultare originali.La mezz'ora di "Welldweller" offre, senza cadute di tono o ammorbamenti che portano allo sfinimento, una bella introduzione sul mondo dei Lothorian. "Witchhunt" e "Atmosphere" sono strumentali e offrono ai nostri la possibilità di correre a briglia sciolta tra un rifferama ultra heavy e cambi di direzione inaspettati. La doppietta "Doomsday Calling" e "Cult" paga un po' troppo il tributo allo Stregone Elettrico ultimo periodo (ma è proprio Jus Osbourne, quello che sentiamo nella coda di "Doomsday Calling"?), senza però risultare fuori contesto. Finale ottimo con il sabbatthismo di "Shallow Ground", il saluto ai maestri, senza i quali nessuno sarebbe potuto essere.
La qualità sembra il tratto distintivo di tutte quelle etichette che nel nostro paese stanno portando avanti la tradizione della musica underground heavy psych doom. Un plauso a questi personaggi che puntano, tra mille difficoltà di ordine economico e promozionale, a portare avanti il discorso. Vero manipolo di eroi a cui noi tutti dovremmo essere riconoscenti. For those about to rock we salute you!
Eugenio Di Giacomantonio
LOUD NINE – Golem
L’esordio sulla lunga distanza e la fitta attività live che li ha gradualmente portati ad aprire per nomi blasonati, stanno facendo finalmente emergere il nome dei Loud Nine (dopo un impercettibile quanto repentino cambio del monicker), capaci di centrare l’obiettivo già al primo colpo.Lo stoner europeo dei tardi anni novanta, con un pizzico della polvere grunge punk dispersa nel nuovo millennio e delle tante esperienze del rock sotterraneo, sono il patrimonio genetico di Morgan, Dave e Fede, che con “Golem” mettono in riga gli ascoltatori con una fitta sequenza di riff ipnotici e linee vocali dall’ottimo feeling. Esemplare tra tutte risulta “Pew”: immaginate Lowrider e Demon Clearer rivisti in un’ottica attuale, tra sensazioni robotiche e caldo groove metropolitano.
In “Artichokes” e “Green Nuts” si impastano Eagles of Death Metal, Mammoth Volume e Mudhoney, mentre le paranoidi “Pink Shark” e “Grandma Frog” fanno pensare a una versione in nero di Queens of the Stone Age e Foo Fighters.
“La marcia dei folli” non è brano prog come potrebbe suggerire il titolo, bensì urticante rock pesante scaturito dai dintorni di Seattle, così come la title-track e “Dark Side of Me” sono anthem mesmerizzanti frutto di una scrittura scorrevole e decisa. Chiusura d’obbligo con la tirata “Rip”, ricca di melodie ispide e contagiose. Non manca molto forse per realizzare un grande album, nel frattempo se volete rock solido e argilloso come l’automa immortalato da Meyrink mettete nel lettore “Golem”.
Roberto Mattei
Lowrider – Refractions
I
Lowrider sono tornati.
Refractions è il loro secondo album, il primo a vent'anni da
Ode to Io, un esordio (preceduto da un memorabile split con i Nebula) sul quale si è discusso molto all'epoca dell'uscita.
Osannati dai nostalgici della golden age of stoner, la band svedese è sempre stata chiara sulle proprie intenzioni: un
sound guitar-driven iper-kyussiano di pura matrice psichedelica. Un signor gruppo, insomma, criticabile semmai perché già alla fine dei '90 una cappa di mediocrità era calata sul genere.
Dallo scioglimento del 2003 il bassista e cantante Peter Bergstran è poi confluito nei
Greenleaf, che non a caso hanno partorito le loro migliori prove con album "di mezzo" come
Nest of Vipers e
Trails and Passes, uno dei più validi e sottovalutati dischi di "stoner adulto" degli anni Duemila.
Chiusi questi capitoli, i Lowrider si riaffacciano sulla scena heavy psych con
Refractions, un album di sei tracce che nello stagnante panorama odierno (a proposito, dove sono gli
Omega Sun?) risulta davvero eccitante. La band, rodata dalle apparizioni degli ultimi tempi su palchi importanti come quelli di Roadburn e Desertfest, suona lo
stoner roccioso e
dilatato dei bei vecchi tempi.
L'ascolto dona un appagante senso di rassicurazione: i Lowrider ti danno esattamente quello che cerchi. Ci sono le palate di groove, i
riff mastodontici e i
fuzz fumosi, i vocals avvolgenti e le
spirali psichedeliche in cui perdersi.
Red River è il classico brano trainante: perfetto per saltare dal divano o costringere i vicini a chiamare la polizia.
Sernanders Krog è la marcia trionfale che reitera il riff giusto fino allo stordimento,
Sun Devil / M87* – espansione dell'intermezzo acustico presente su
Ode to Io – è la strumentale che riesce a portarti altrove,
Ode to Ganymede possiede una grazia magica e sospesa con quell'organo Hammond che spunta così all'improvviso.
Tutto è al posto esatto, persino i caricati sapori à la Electric Wizard che aprono
Ol' Mule Pepe (altro reprise rivisto e corretto dai tempi del debutto) prima che diventi un bolide capace di azzeccare il mood fangoso della vita. Il refrain così sussurrato ed intenso che accompagna l'addio straziante della conclusiva
Pipe Rider è una nota di classe compositiva che persino i detrattori non possono ignorare.
Diamo il bentornato ai Lowrider e al loro suono sporco e accorato, polveroso e sincero. Se siete a caccia di un disco stoner che valga davvero la pena ascoltare, fermate la ricerca:
Refractions è ciò che fa al caso vostro.
https://www.youtube.com/watch?v=OHCiieXDQFc
Alessandro Zoppo
LUCIFERI – V
Vengono dalla ridente Parma i sinistri Luciferi, e debuttano con l'EP dal titolo laconico "V". Ostentando una forte ispirazione per tutto ciò che è post e noise e viene dai '90, il power trio produce un lavoro a tratti interessante ma spesso confuso e privo di una linea guida. Se l'opener "Dante ci ha cacciato dal nostro Inferno" parte al fulmicotone e ricorda alla lontana gli American Rampage di "Ethereal Killer", subito dopo l'andamento funky di "Cerbero" tende a spegnere gli entusiasmi: sembra di sentire i Calibro 35 in overdose di fuzz. Con "Faust" il tiro si aggiusta decisamente, partono droni e feedback sinistri, si innesta una marcia lugubre e oscura che prelude ad un finale in crescendo, quasi epico. "Fiat Lux" vaga invece senza meta, mentre la conclusiva "Strange Sense of Violence" con il suo riff bucolico su campionamenti industrial e ambient risulta troppo stralunata e scanzonata per essere presa sul serio. Debutto incoraggiante ma sicuramente da rivedere, a riprova che le buone ispirazioni e le buone intenzioni a volte non bastano.
Giuseppe Aversano
LUKE ROBERTS – The Iron Gates at Throop and Newport
Un paesaggio infinito e assolato. Un amore da ricordare con gioia e nostalgia. Il piacere di una passeggiata in una giornata di primavera. La ricerca di noi stessi in questo folle mondo. Piccole emozioni che scaturiscono da gesti e sensazioni quotidiane. Bozzetti raccontati con delicatezza acustica da Luke Roberts nel suo nuovo disco "The Iron Gates at Throop and Newport". Seguito dell'esordio "Big Bells and Dime Songs", il cantautore sfoggia ancora la sua Collings modello 000 2H e affronta un viaggio di ritorno, da Brooklyn al Montana fino a Nashville, suo paese d'infanzia. È proprio lì che lo immaginiamo ascoltare i suoi idoli Neil Young, Bob Dylan e David Crosby e strimpellare i primi accordi. Prodotto da Marky Nevers (Lambchop), mixato da Kyle Spence (Harvey Milk) ed edito dalla Thrill Jockey, "The Iron Gates at Throop and Newport" compie un incredibile passo in avanti rispetto al debut album. Il songwriting si è fatto maturo, più complesso e stratificato. Allo stoned folk si accompagnano rurali cadenze country blues dal fascino secolare. La ricchezza degli arrangiamenti è notevole: non solo chitarra acustica, voce e consuete spoken lyrics, ma anche il violino ed il mandolino di Billy Contraraz, le vocals di Emily Sunblad, l'armonica di Ryan Suther, inserti sorprendenti di batteria, sparsi brividi elettrici e tocchi dolci di pianoforte.Vita vissuta, lotte personali, inferno e redenzione. Famiglia, amore, speranza. Sorrisi, fughe, sbandamenti. Di questo ci parla Luke Roberts. Lo fa con la delicatezza di un fratello maggiore nelle tenui "I Don't Want You Anymore", "Cartier Timepiece" e "Second Place Blues"; azzeccando un chorus magnetico nella stupenda "His Song" (quella chitarra elettrica scuote fino al midollo); dipingendo emozioni in punta di plettro in "Every Time" e "Will You Be Mine". Un'America ancora in piedi, seppure con le ossa rotte, fatte a pezzi. Cantata con un approccio minimalista struggente. Come dimostra "Spree Wheels", una delle più belle canzoni ascoltate negli ultimi anni. Malinconia in fondo alla quale vediamo la speranza, perché Tutto risiede nella Bellezza ("Old Fashioned Woman", altra chitarra elettrica che scatena lacrime) e nel Ritmo che solo la Musica ci può donare ("Lost on Leaving").
I'm comin' to see you, I'm singin' my good-byes. I'll be the one who you don't recognize...
Alessandro Zoppo
Lydsyn – Lydsyn
Dopo un lungo e travagliato periodo, torna l’amato
Lorenzo Woodrose con una band tutta nuova: i
Lydsyn. Un power trio come si faceva una volta, ma in questo caso siamo lontani dai
Baby Woodrose.
In questo disco d'esordio cantato completamente in danese, registrato, mixato e masterizzato da Flemming Rasmussen ai celebri studi Sweet Silence di Copenhagen, Uffe abbraccia il rock a tutto tondo, per non dire esplicitamente l’
hard rock. Un tuffo di pancia dentro i classici degli anni Settanta, con un’inclinazione particolare verso le band storiche come Deep Purple, AC/DC, Led Zeppelin e via di seguito.
Sembra che questa volta il timone non sia solo in mano a Lorenzo. I due compari di brigata,
Palle Demant al basso e
Jens Eyde alla batteria, fanno sentire la loro influenza in sede di composizione.
Lo stile inconfondibile di Lorenzo, una verace e vivida continuazione del grande Roky Erickson, tocca in punta di fioretto perle preziose come “To Syge Skud” e “Tårnet” – quasi due out-take del bellissimo “
Magisk Realisme”, realizzato a nome proprio – “Hymne Til Kroppen” (cover di un brano del 1978 dei misconosciuti Splask) e la finale “Bålet”. Ma nell’ascolto dell’album giungono
espressioni blues, acustiche, roots, che, se da una parte incuriosiscono, dall’altra non generano la meraviglia a cui siamo abituati nella scoperta elettrizzante delle altre band di Lorenzen.
Non un passo falso, ci mancherebbe, anche perché i nove pezzi di questo album d’esordio dei Lydsyn (sempre sotto l’egida di
Bad Afro) sono una spanna sopra tutto quello che viene definito psichedelia moderna. Ma
una mancata festa lisergica. Come se un amico ti fosse venuto a trovare senza portare niente da bere.
Magari è come un buon vino: il tempo gli darà forza e carattere.
https://www.youtube.com/watch?v=1yGEnpAjsPE&ab_channel=badafrorecords
Eugenio Di Giacomantonio
LYMPH OF WISDOOM – Listen
Grande sorpresa questi Lymph of Wisdoom di Asti, band formata nel novembre 2000 dal chitarrista Daniele Cagnotto (all’epoca membro dei Mortuary Drape). Questo nuovissimo “Listen” (terzo lavoro del gruppo) rappresenta una delle più liete e notevoli sorprese uscite dell’underground italiano. Partiti come doom metal band, i nostri hanno col tempo incorporato all’interno del loro suono influenze seventies e stoner rock, arrivando a proporre oggi un potentissimo impasto sonoro che rimanda ai Black Label Society e a qualcosa dei Cathedral più rock (quelli di “Caravan beyond redemption” per intenderci).Colpisce la capacità del trio di saper comporre canzoni trascinanti, dalle strutture efficaci e dotate di refrain memorabili (“Going down” e “The summer of pain” sono due grandi song che si stampano in testa dopo il primo ascolto). Ottima la cover di “Never let me down again” (Depeche Mode) che, pur riproposta in una rocciosa versione rock, non perde la malinconia dell’originale. La conclusiva “Still down” è una breve jam song che sono sicuro dal vivo (magari proposta in una versione allungata) regalerà intense emozioni. Un gruppo assolutamente pronto al debutto ufficiale: fan ed etichette fatevi sotto.
Marco Cavallini


 L'Ira del Baccano[/caption]
Eugenio Di Giacomantonio
L'Ira del Baccano[/caption]
Eugenio Di Giacomantonio
 Lord Woland[/caption]
Eugenio Di Giacomantonio
Lord Woland[/caption]
Eugenio Di Giacomantonio
 Lost Moon[/caption]
Alessandro Zoppo
Lost Moon[/caption]
Alessandro Zoppo